Quando, una quindicina di anni fa, Caterina Vecchiato mi propose di contribuire con uno scritto al volume Il senso della psichiatria. Incontro tra psicoanalisi, psicopatologia e letteratura (Redancia ed., 2006) le proposi uno scritto, Il senso della psichiatria: la Storia, le storie, che nasceva dal confronto tra storie cliniche raccolte in due momenti lontani della psichiatria italiana. Da un lato, quelle che Giovanni Stefano Bonacossa (1804-1878) presentava agli studenti di medicina dell’Università di Torino intorno al 1850 durante un “giro” del suo reparto; dall’altro, alcune di quelle nelle quali mi ero imbattuto durante quei primi quindici anni di lavoro nella psichiatria italiana della Legge 180. Cosa c’è di costante nel senso del fare psichiatria in quei due momenti – mi ero chiesto – e cosa è cambiato dopo un secolo e mezzo?
La stessa operazione ho pensato di compiere quest’estate, leggendo due libri freschi di stampa, in entrambi i casi usciti negli stessi giorni del mio Ritorno a Basaglia? e in entrambi i casi dedicati a storie di psichiatria, appartenenti però a periodi anche in questo caso lontani tra loro. Nel primo caso si tratta di Storie dal manicomio (Clueb, 2022) dello storico reggiano Francesco Paolella; nel secondo di CIM. Cento imperfetti mondi (Albatros, 2022) degli psichiatri liguri Giacinto Buscaglia e Franca Pezzoni.
Il libro di Paolella raccoglie undici storie cliniche di soggetti internati nel manicomio di San Lazzaro, a Reggio Emilia – in quegli anni il più importante in Italia – tra gli anni ’70 dell’Ottocento e gli anni ’40 del Novecento. Per ciascuna di esse Paolella parte dal materiale d’archivio ma poi, quando gli è possibile, si sposta a interrogare altre fonti, curioso di ricostruire il prima e il dopo dell’internamento al San Lazzaro. È un modo, mi pare, per sottrarsi al duplice rischio che Luciano Del Pistoia paventa – in un saggio, pubblicato l'anno scorso, sul quale varrà senz’altro la pena di ritornare su questa rubrica (Dialogo con l’insensato. Introduzione storica e clinica alla psicopatologia fenomenologica, Alpes) – per le storie tratte dalle cartelle cliniche: quello di concentrarsi su un periodo limitato della vita della persona, corrispondente all’internamento, e quello di essere filtrate dallo sguardo psichiatrico.
Così, le sue storie restituiscono un’immagine del manicomio, certo, ma anche dell’Italia di allora a partire dalla prima, quella di Adele, la bambina di campagna che giocando con un’amica afferma di aver visto l’immagine della Madonna in un cespuglio. A seguito del conflitto che si accende tra devozione popolare e intervento della forza pubblica a tutela dell’ordine, il cespuglio finisce per essere sradicato e Adele finisce in osservazione al San Lazzaro, dove rimane per due mesi oggetto di studio per gli psichiatri, incaricati di ridurre quel fenomeno perturbante a oggetto scientifico.
Segue la vicenda di Achille Paganini, l’eccentrico figlio del famoso, ed egli pure eccentrico, musicista Niccolò, che viene internato già anziano al San Lazzaro per qualche mese nel 1889 tra i ricoverati “di prima classe”, ai quali era riservata una sistemazione alberghiera più confortevole rispetto ai comuni internati. Ricoverato con l’inganno su iniziativa dei figli (sulla questione dell’inganno in psichiatria avremo modo di ritornare oltre), Achille è alloggiato, durante la permanenza, al Villino Livi dove, apprendiamo, era possibile essere assistiti dai propri domestici e da infermieri travestiti, per non turbare l’illustre ospite, da giardinieri. Accanto alla ricostruzione della storia di Achille, Paolella coglie l’opportunità di fornire informazioni sulla vita del padre e il funzionamento dei Villini, il cui progetto era stato proposto nel 1874 da Carlo Livi al Congresso della Società Freniatrica di Imola, riservati agli internati più ricchi.
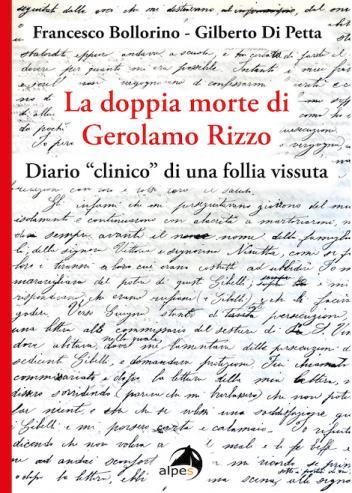 Tra le storie più interessanti è senz’altro la terza, oggetto tra altri di un saggio sulla paranoia di Eugenio Tanzi e Gaetano Riva nel 1886. Della vicenda dell’avvocato morfinomane mi ha colpito la somiglianza con il caso di un insegnante ricoverato nei manicomi genovesi una ventina d’anni dopo, del quale ci siamo occupati due anni fa in un testo che ha ricevuto molte recensioni su Pol. it (Bollorino F., Di Petta G., La doppia morte di Gerolamo Rizzo. Diario clinico di una follia vissuta, Roma, Alpes, 2020). Ad avvicinare le due vicende non sono solo il fatto che entrambe abbiano a che fare con la paranoia, ed entrambe possano essere ricostruite a partire da un prezioso scritto autobiografico del protagonista ritrovato nella cartella clinica che dà, in entrambi i casi, la sensazione di poter «entrare in una mente delirante», come scrive Paolella, ma anche il rilievo che in entrambi i casi assume nel contenuto del delirio un fenomeno che rappresentava in quei decenni una potenza che, per la rapida evoluzione, destava entusiasmi nei futuristi ma anche inquietudini, evidentemente, nei soggetti più fragili, cioè la tecnologia dalla quale entrambi i soggetti sentono il proprio spazio mentale violato, invaso, in balia di altri.
Tra le storie più interessanti è senz’altro la terza, oggetto tra altri di un saggio sulla paranoia di Eugenio Tanzi e Gaetano Riva nel 1886. Della vicenda dell’avvocato morfinomane mi ha colpito la somiglianza con il caso di un insegnante ricoverato nei manicomi genovesi una ventina d’anni dopo, del quale ci siamo occupati due anni fa in un testo che ha ricevuto molte recensioni su Pol. it (Bollorino F., Di Petta G., La doppia morte di Gerolamo Rizzo. Diario clinico di una follia vissuta, Roma, Alpes, 2020). Ad avvicinare le due vicende non sono solo il fatto che entrambe abbiano a che fare con la paranoia, ed entrambe possano essere ricostruite a partire da un prezioso scritto autobiografico del protagonista ritrovato nella cartella clinica che dà, in entrambi i casi, la sensazione di poter «entrare in una mente delirante», come scrive Paolella, ma anche il rilievo che in entrambi i casi assume nel contenuto del delirio un fenomeno che rappresentava in quei decenni una potenza che, per la rapida evoluzione, destava entusiasmi nei futuristi ma anche inquietudini, evidentemente, nei soggetti più fragili, cioè la tecnologia dalla quale entrambi i soggetti sentono il proprio spazio mentale violato, invaso, in balia di altri.
Si ritorna al mondo rurale con il suo difficile rapporto con la modernità e alla superstizione con la quarta storia, relativa a cinque giovani di Sassuolo un po’ creduloni e dediti a culti esoterici e al furto di un libro, che credono dotato di poteri magici. Giudici e periti psichiatri scrivono il resto di questa storia, sforzandosi d’interpretarla secondo i codici rispettivi. Evidentemente, l’Italia che Paolella coglie in queste storie è un’Italia in bilico tra superstizione e progresso tecnologico, nella quale il mondo e la cultura della campagna stentano a lasciare pieno campo al “progresso”.
È poi la volta di Ersilia e del dolce, ingenuo e insistente amore omosessuale originato sul lavoro che la porta in manicomio, caduto proprio negli anni – Paolella documenta – di massima patologizzazione dell’omosessualità da parte della scienza psichiatrica.
Arminio era stato, poco prima dell’internamento, autore di un racconto pubblicato su una rivista letteraria locale, che consente di gettare maggior luce sulla vicenda di quanto consentirebbe la scarna documentazione clinica.
Ugo Zaneboni fu un caso assai noto ai suoi tempi per la capacità prodigiosa per i calcoli, e ciò ne fece l’oggetto di un saggio degli psichiatri Guicciardi e Ferrari sulla Rivista Sperimentale di Freniatria. Si tratta di uno di quei casi di ipermnesia che, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, attrassero l’attenzione dei primi studiosi di psicologia a partire da Theodule-Armand Ribot e Alfred Binet in Francia, il più noto dei quali fu forse Inaudi.
Tra di essi, fu noto il caso di Salomon Seresevskij, studiato a partire dagli anni ’20 del Novecento in Unione Sovietica da Aleksandr Romanovic Lurija, la cui riduzione teatrale a opera di Daniela Ardini e dell’Associazione Teatrale genovese “Lunaria” nel 2004 avevo commentato a mia volta (M.A. Ortega Pardal, P.F. Peloso, Ricordare troppo. Ipermnesia in scena nell’estate genovese, Il vaso di Pandora, 12, 3, pp. 123-134).
La vicenda del vogherese Francesco Baratta, ricostruita nell’indagine a tutto campo di Paolella, gli consente un accenno ai ricoveri al San Lazzaro di soggetti che, in giovane età, avevano preso parte all’epopea garibaldina, mentre quella di Don Luigi gli permette di riprendere un suo precedente studio sui ricoveri di religiosi al San Lazzaro e i loro spesso non facili rapporti con gli psichiatri, laici e positivisti. Inutili gli appelli del prelato per ricevere aiuto da altri sacerdoti, o dai familiari.
La vicenda di Ercole evoca un altro tema interessante per la storia della psichiatria, ma anche per la psichiatria di oggi e i suoi confini, quello della “pazzia morale”. Ma permette anche all’autore di toccare altre questioni: l’emigrazione oltre oceano, esperienza comune a tanti italiani negli anni da lui considerati, lo svolgimento truffaldino della professione medica senza averne la qualifica, il ricorso alla poesia e all’autobiografia per lasciare la propria testimonianza, comune a tanti internati nei manicomi (per tutti, ricordo Giovanni Antonelli, il poeta anarchico marchigiano del quale mi sono occupato sulla Rivista Sperimentale di Freniatria: Enrico Morselli e Giovanni Antonelli: l’alienista e il suo genio, 143, 2019, 1, pp. 147-169).
La stessa operazione ho pensato di compiere quest’estate, leggendo due libri freschi di stampa, in entrambi i casi usciti negli stessi giorni del mio Ritorno a Basaglia? e in entrambi i casi dedicati a storie di psichiatria, appartenenti però a periodi anche in questo caso lontani tra loro. Nel primo caso si tratta di Storie dal manicomio (Clueb, 2022) dello storico reggiano Francesco Paolella; nel secondo di CIM. Cento imperfetti mondi (Albatros, 2022) degli psichiatri liguri Giacinto Buscaglia e Franca Pezzoni.
Il libro di Paolella raccoglie undici storie cliniche di soggetti internati nel manicomio di San Lazzaro, a Reggio Emilia – in quegli anni il più importante in Italia – tra gli anni ’70 dell’Ottocento e gli anni ’40 del Novecento. Per ciascuna di esse Paolella parte dal materiale d’archivio ma poi, quando gli è possibile, si sposta a interrogare altre fonti, curioso di ricostruire il prima e il dopo dell’internamento al San Lazzaro. È un modo, mi pare, per sottrarsi al duplice rischio che Luciano Del Pistoia paventa – in un saggio, pubblicato l'anno scorso, sul quale varrà senz’altro la pena di ritornare su questa rubrica (Dialogo con l’insensato. Introduzione storica e clinica alla psicopatologia fenomenologica, Alpes) – per le storie tratte dalle cartelle cliniche: quello di concentrarsi su un periodo limitato della vita della persona, corrispondente all’internamento, e quello di essere filtrate dallo sguardo psichiatrico.
Così, le sue storie restituiscono un’immagine del manicomio, certo, ma anche dell’Italia di allora a partire dalla prima, quella di Adele, la bambina di campagna che giocando con un’amica afferma di aver visto l’immagine della Madonna in un cespuglio. A seguito del conflitto che si accende tra devozione popolare e intervento della forza pubblica a tutela dell’ordine, il cespuglio finisce per essere sradicato e Adele finisce in osservazione al San Lazzaro, dove rimane per due mesi oggetto di studio per gli psichiatri, incaricati di ridurre quel fenomeno perturbante a oggetto scientifico.
Segue la vicenda di Achille Paganini, l’eccentrico figlio del famoso, ed egli pure eccentrico, musicista Niccolò, che viene internato già anziano al San Lazzaro per qualche mese nel 1889 tra i ricoverati “di prima classe”, ai quali era riservata una sistemazione alberghiera più confortevole rispetto ai comuni internati. Ricoverato con l’inganno su iniziativa dei figli (sulla questione dell’inganno in psichiatria avremo modo di ritornare oltre), Achille è alloggiato, durante la permanenza, al Villino Livi dove, apprendiamo, era possibile essere assistiti dai propri domestici e da infermieri travestiti, per non turbare l’illustre ospite, da giardinieri. Accanto alla ricostruzione della storia di Achille, Paolella coglie l’opportunità di fornire informazioni sulla vita del padre e il funzionamento dei Villini, il cui progetto era stato proposto nel 1874 da Carlo Livi al Congresso della Società Freniatrica di Imola, riservati agli internati più ricchi.
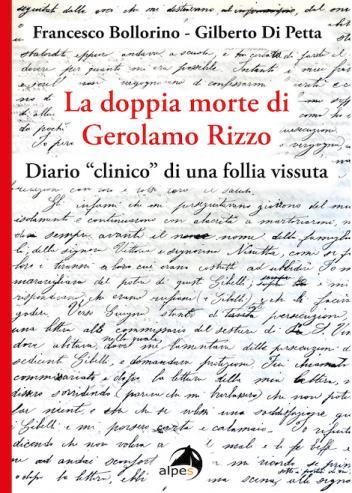 Tra le storie più interessanti è senz’altro la terza, oggetto tra altri di un saggio sulla paranoia di Eugenio Tanzi e Gaetano Riva nel 1886. Della vicenda dell’avvocato morfinomane mi ha colpito la somiglianza con il caso di un insegnante ricoverato nei manicomi genovesi una ventina d’anni dopo, del quale ci siamo occupati due anni fa in un testo che ha ricevuto molte recensioni su Pol. it (Bollorino F., Di Petta G., La doppia morte di Gerolamo Rizzo. Diario clinico di una follia vissuta, Roma, Alpes, 2020). Ad avvicinare le due vicende non sono solo il fatto che entrambe abbiano a che fare con la paranoia, ed entrambe possano essere ricostruite a partire da un prezioso scritto autobiografico del protagonista ritrovato nella cartella clinica che dà, in entrambi i casi, la sensazione di poter «entrare in una mente delirante», come scrive Paolella, ma anche il rilievo che in entrambi i casi assume nel contenuto del delirio un fenomeno che rappresentava in quei decenni una potenza che, per la rapida evoluzione, destava entusiasmi nei futuristi ma anche inquietudini, evidentemente, nei soggetti più fragili, cioè la tecnologia dalla quale entrambi i soggetti sentono il proprio spazio mentale violato, invaso, in balia di altri.
Tra le storie più interessanti è senz’altro la terza, oggetto tra altri di un saggio sulla paranoia di Eugenio Tanzi e Gaetano Riva nel 1886. Della vicenda dell’avvocato morfinomane mi ha colpito la somiglianza con il caso di un insegnante ricoverato nei manicomi genovesi una ventina d’anni dopo, del quale ci siamo occupati due anni fa in un testo che ha ricevuto molte recensioni su Pol. it (Bollorino F., Di Petta G., La doppia morte di Gerolamo Rizzo. Diario clinico di una follia vissuta, Roma, Alpes, 2020). Ad avvicinare le due vicende non sono solo il fatto che entrambe abbiano a che fare con la paranoia, ed entrambe possano essere ricostruite a partire da un prezioso scritto autobiografico del protagonista ritrovato nella cartella clinica che dà, in entrambi i casi, la sensazione di poter «entrare in una mente delirante», come scrive Paolella, ma anche il rilievo che in entrambi i casi assume nel contenuto del delirio un fenomeno che rappresentava in quei decenni una potenza che, per la rapida evoluzione, destava entusiasmi nei futuristi ma anche inquietudini, evidentemente, nei soggetti più fragili, cioè la tecnologia dalla quale entrambi i soggetti sentono il proprio spazio mentale violato, invaso, in balia di altri.
Si ritorna al mondo rurale con il suo difficile rapporto con la modernità e alla superstizione con la quarta storia, relativa a cinque giovani di Sassuolo un po’ creduloni e dediti a culti esoterici e al furto di un libro, che credono dotato di poteri magici. Giudici e periti psichiatri scrivono il resto di questa storia, sforzandosi d’interpretarla secondo i codici rispettivi. Evidentemente, l’Italia che Paolella coglie in queste storie è un’Italia in bilico tra superstizione e progresso tecnologico, nella quale il mondo e la cultura della campagna stentano a lasciare pieno campo al “progresso”.
È poi la volta di Ersilia e del dolce, ingenuo e insistente amore omosessuale originato sul lavoro che la porta in manicomio, caduto proprio negli anni – Paolella documenta – di massima patologizzazione dell’omosessualità da parte della scienza psichiatrica.
Arminio era stato, poco prima dell’internamento, autore di un racconto pubblicato su una rivista letteraria locale, che consente di gettare maggior luce sulla vicenda di quanto consentirebbe la scarna documentazione clinica.
Ugo Zaneboni fu un caso assai noto ai suoi tempi per la capacità prodigiosa per i calcoli, e ciò ne fece l’oggetto di un saggio degli psichiatri Guicciardi e Ferrari sulla Rivista Sperimentale di Freniatria. Si tratta di uno di quei casi di ipermnesia che, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, attrassero l’attenzione dei primi studiosi di psicologia a partire da Theodule-Armand Ribot e Alfred Binet in Francia, il più noto dei quali fu forse Inaudi.
Tra di essi, fu noto il caso di Salomon Seresevskij, studiato a partire dagli anni ’20 del Novecento in Unione Sovietica da Aleksandr Romanovic Lurija, la cui riduzione teatrale a opera di Daniela Ardini e dell’Associazione Teatrale genovese “Lunaria” nel 2004 avevo commentato a mia volta (M.A. Ortega Pardal, P.F. Peloso, Ricordare troppo. Ipermnesia in scena nell’estate genovese, Il vaso di Pandora, 12, 3, pp. 123-134).
La vicenda del vogherese Francesco Baratta, ricostruita nell’indagine a tutto campo di Paolella, gli consente un accenno ai ricoveri al San Lazzaro di soggetti che, in giovane età, avevano preso parte all’epopea garibaldina, mentre quella di Don Luigi gli permette di riprendere un suo precedente studio sui ricoveri di religiosi al San Lazzaro e i loro spesso non facili rapporti con gli psichiatri, laici e positivisti. Inutili gli appelli del prelato per ricevere aiuto da altri sacerdoti, o dai familiari.
La vicenda di Ercole evoca un altro tema interessante per la storia della psichiatria, ma anche per la psichiatria di oggi e i suoi confini, quello della “pazzia morale”. Ma permette anche all’autore di toccare altre questioni: l’emigrazione oltre oceano, esperienza comune a tanti italiani negli anni da lui considerati, lo svolgimento truffaldino della professione medica senza averne la qualifica, il ricorso alla poesia e all’autobiografia per lasciare la propria testimonianza, comune a tanti internati nei manicomi (per tutti, ricordo Giovanni Antonelli, il poeta anarchico marchigiano del quale mi sono occupato sulla Rivista Sperimentale di Freniatria: Enrico Morselli e Giovanni Antonelli: l’alienista e il suo genio, 143, 2019, 1, pp. 147-169).
Chiude questa galleria di personaggi Dorina, che ha conosciuto da bimba l’internamento come frenastenica e poi vi ha fatto ritorno da adulta, ed è la sua vicenda a condurci attraverso i mondi della prostituzione, della marginalità e anche del crimine.
Le undici storie raccolte da Paolella nell’archivio del San Lazzaro, insomma, mi pare che testimonino nel loro insieme come in manicomio si potesse entrare da tante porte, a partire da vicende di vita, molto diverse l’una dall’altra. E come si potesse trovare la porta dell’uscita dopo un tempo relativamente breve o dopo un tempo lungo, a volte lunghissimo. Come si potesse uscire, per poi ritornare; oppure no.
Costituiscono uno spaccato che gli consente, attraverso lo stile narrativo piacevole della scrittura di microbiografie, di gettare una luce su cos’era la psichiatria in quei decenni a cavallo tra Otto e Novecento; una psichiatria che non si presenta, in queste pagine, negli aspetti più drammatici o più tragici che della vicenda del manicomio certo sono una parte importante, ma che appare qui impegnata in un’attività curiosa di identificazione e di studio di quel qualcosa di “strano”, di ”anormale” che costituisce la follia nell’infinita varietà delle sue possibili declinazioni.
Una psichiatria curiosa, per riprendere il dilemma che Sergio Zavoli pose a Franco Basaglia in una nota intervista televisiva (vai al link), decisamente più interessata alla malattia – alla sua osservazione e alla spiegazione, ove possibile, delle sue cause – che al malato.
Siamo cioè in questi casi ancora all’interno, almeno a valutare dalle tracce che i documenti hanno tramandato, di quella «riduzione obiettivante del paziente psichiatrico a cui approda la neuropsichiatria nel suo affermarsi (a cavallo tra ‘800 e ‘900) e che comporta la esclusione della significanza semeiologica delle emozioni e sentimenti che il paziente possa suscitare nell’esaminatore» alla quale Luciano Del Pistoia fa correlativamente riferimento nel saggio del quale già si è detto.
E, insieme a uno spaccato di quella psichiatria, offrono anche uno spaccato di com’era, in quegli anni, l’Italia: la sua borghesia e la relativa ricerca, anche attraverso l’esclusione psichiatrica, di una tranquillizzante, e forse un po’ ipocrita e a volte un po’ crudele, normalità.
 Tutt’altra psichiatria è quella della quale si occupa il secondo volume che consideriamo – CIM. Cento imperfetti mondi – che è anch’esso una raccolta di storie, o più precisamente dovrei scrivere di incontri, esplorazioni del mondo che l’altro, caso per caso, costituisce. E in questo si coglie una differenza importante tra le psichiatrie che sono oggetto dei due volumi: da un lato la psichiatria positivista e la storia del paziente come mero oggetto di osservazione dello psichiatra, che s’imbatte in un’esistenza, la descrive, la studia, ma non entra in relazione con essa, o almeno non lascia traccia, nel documentare la vicenda, di questa relazione. Lo psichiatra descrive, ed è fuori scena. Dall’altro lato, la psichiatria dei nostri servizi, alla quale la psicoanalisi e la fenomenologia hanno insegnato a fare delle risonanze che evoca nell’osservatore l’incontro con l’altro, la luce per può permettere di cogliere, e in qualche misura arrivare a volte a comprendere, il suo particolare (forse imperfetto, certo) mondo, per poi raccontarlo attraverso il filtro dell’esperienza che se ne è fatta.
Tutt’altra psichiatria è quella della quale si occupa il secondo volume che consideriamo – CIM. Cento imperfetti mondi – che è anch’esso una raccolta di storie, o più precisamente dovrei scrivere di incontri, esplorazioni del mondo che l’altro, caso per caso, costituisce. E in questo si coglie una differenza importante tra le psichiatrie che sono oggetto dei due volumi: da un lato la psichiatria positivista e la storia del paziente come mero oggetto di osservazione dello psichiatra, che s’imbatte in un’esistenza, la descrive, la studia, ma non entra in relazione con essa, o almeno non lascia traccia, nel documentare la vicenda, di questa relazione. Lo psichiatra descrive, ed è fuori scena. Dall’altro lato, la psichiatria dei nostri servizi, alla quale la psicoanalisi e la fenomenologia hanno insegnato a fare delle risonanze che evoca nell’osservatore l’incontro con l’altro, la luce per può permettere di cogliere, e in qualche misura arrivare a volte a comprendere, il suo particolare (forse imperfetto, certo) mondo, per poi raccontarlo attraverso il filtro dell’esperienza che se ne è fatta.
Certo la psichiatria è cambiata, non foss’altro per questo; ma poi anche per i luoghi del suo svolgersi, che dal manicomio sono adesso i luoghi più vari, e a volte più strani, nei quali si svolge la vita reale (al termine del volume ne sono elencati una cinquantina). E poi certo per molto altro, nel secolo che separa tra loro le 100 vicende oggetto di questo secondo volume dalle 11 oggetto del primo.
Ma, accanto a cose che cambiano, ci sono anche cose che ritornano: come quando la psichiatra è chiamata a intervenire nei nostri anni nel corso di una crisi mistica nella cattedrale e al leggerne perdiamo il senso del tempo: non sappiamo più se la scena si svolge nel madioevo quando la cattedrale è stata costruita con le sue allegorie marmoree allora certo più evocative di oggi, nell’Ottocento di Paolella o nell’oggi in cui si muovono Buscaglia e Pezzoni.
Il sacro, evidentemente, è tra i dilemmi che l’uomo porta attraverso il tempo con sé; e in ogni tempo può evocare risposte imperfette, e sfidare alla loro lettura.
Narrare storie, le storie diverse che ieri portavano al manicomio e oggi portano alla chiamata al CIM, è un’operazione nella quale i due autori di CIM, voltandosi indietro subito dopo essere andati in pensione, si cimentano in questo caso cento volte. Cento mondi diversi, appunto, incontrati nel corso delle loro carriere: lui di psichiatra di campagna e di mare, avendo esercitato soprattutto nella zona delle cittadine rivierasche di ponente della provincia di Savona e del loro entroterra, lei psichiatra urbana, avendo esercitato – dopo un breve passaggio anche lei per il Savonese – soprattutto a Genova, nella zona del Centro storico.
Buscaglia e Pezzoni hanno fatto a tempo a vedere nei loro primi anni di lavoro, ancora il manicomio, dove andavano a conoscere i pazienti prossimi alla dimissione. Ma operano in una psichiatria che si è lasciata il manicomio alle spalle. Toccano a volte l’ospedale, il mondo della corsia «con una guardiola al centro per gli infermieri, le stanze dei medici dove si fa il caffè, gli scaffali per le cartelle, l’arrivo dei consulenti, gli elettrocadiogrammi, le rivalità al coltello tra i medici strutturati che, in realtà, sono la vera attività clinica di tutti i reparti (…). I pazienti sono in pigiama, i sanitari in camice. Tutto va avanti con un suo ritmo, in fondo rassicurante: il giro al mattino, le ore vuote al pomeriggio».
Ma il loro lavoro si svolge prevalentemente nel territorio, nei luoghi vari e strani della vita vera delle persone, e scrivono a un certo punto: «mi sembra che ci sia un abisso tra osservare le persone nel loro ambiente naturale e vederle chiuse in gabbia come allo zoo».
Hanno vissuto il tempo nel quale, prima della metà degli anni ’90, i CSM in Liguria curavano sia i disturbi psichiatrici intesi in senso stretto che la tossicodipendenza.
Sul piano dell’attività letteraria, costituiscono ormai una coppia affiatata: nel 2004 hanno dato alle stampe Parlare di follia. Esperienze di vita quotidana nella pratica psichiatrica (De Ferrari), nel 2018 si sono cimentati con la narrativa, nella quale entrambi si erano già sperimentati individualmente, con il noir L’artiglio del grifone (Araba Fenice).
CIM – centro di igiene mentale – è la denominazione dei primi embrioni di servizi psichiatrici diffusi sul territorio negli anni ’60, ed è rimasta la sigla con la quale, soprattutto in provincia di Savona dove ad essa tutti – operatori, utenti ecc. – paiono affettivamente legati, ci si riferisce ancora oggi nel linguaggio corrente ai CSM (Centri di Salute Mentale).
Non potrò, con questa recensione, certo riproporre ciascuno dei cento mondi sui quali gli autori ci permettono di affacciarci. Né potrò certo fare assaggiare il pregio letterario della loro narrazione che ne costituisce, per Paolo Milone che è autore della prefazione, l’aspetto più importante da considerare. Mi limiterò, quindi, a trarre spunto da qualcuna di queste storie per cogliere gli aspetti più critici del lavoro degli autori, nel quale riconosco fortemente il mio come credo che potranno fare altri.
Certo sono relazioni strane, queste che si stabiliscono nell’attività del CIM. Relazioni che hanno a che fare con il lavoro (il lavoro d’aiuto), ma inevitabilmente anche con la vita. E giustamente commentano gli autori: «la prima cosa che si insegna a un operatore è di non farsi coinvolgere, di non confondere il piano professionale con quello personale». Ma lo scrivono per dire subito dopo che non è facile, e forse neppure è proprio possibile, mantenere fermo il limite quando una relazione si prolunga negli anni, quando le emozioni che passano tra i due che ne sono protagonisti sono di quelle più intense.
Nel territorio, più che nell’ospedale dove le relazioni sono più brevi, l’istituzione è più incombente e le difese a salvaguardia del setting sono più rigide, le relazioni che tendono a stabilirsi non possono davvero a volte prescindere da una dimensione personale, che ha a che fare con l’autentica vita. È così ad esempio quando un’infermiera piange perché Paolo è morto improvvisamente d’infarto, e uno degli autori commenta: «Sono orgoglioso di lei e del suo cuore grande, capace di curare più di qualsiasi medicina». O quando l’altro autore si imbatte sulla strada in storie commuoventi che hanno a che fare con emozioni che sono comuni a ogni persona, da una parte o dall’altra del setting, e può così capitare che una lacrima, di nascosto, «sciolga il mascara».
La vicenda di Paolo ci introduce anche a un tema delicato, del quale si parla di rado: l’uso dell’inganno per curare, che in questo testo ricorre in due occasioni. Quella stessa infermiera confessa infatti al medico di avere in un’occasione ingannato il paziente, sfruttando la sua buona fede e il suo delirio, quando si era trattato di ottenere la sua firma in calce alla domanda per la pensione d’invalidità. È una questione che ritorna oltre, nel caso di Giobatta che non vuole più mangiare né bere e viene convinto a farlo, facendo leva sulla logica stessa del suo delirio.
Non c’erano ancora la Legge 180 e la psichiatria nel territorio, anzi non c’era proprio ancora la psichiatria, quando un sacerdote generoso e dotato di senso pratico, padre Antero Maria Micone, si trovava a metà del ‘600, in piena peste, a dirigere il lazzaretto genovese della Consolazione. Gli posero lo stesso problema nel quale si trova in tutt’altro contesto il giovane psichiatra di Giobatta: convincere un uomo con delirio di avvelenamento a cibarsi, perché non muoia di fame. E la soluzione che trovò allora fu la stessa: ingannare il paziente, manipolando la logica del suo delirio. Una tattica uguale, del resto, utilizzavano in quegli stessi anni gli amici di don Chisciotte al termine del primo volume, per riportarlo a casa.
Si tratta di situazioni, a quattro secoli di distanza, nelle quali rendere il delirio compatibile con la sopravvivenza viene considerato più importante che imporre alla falsa verità del delirio la vera verità. Tattiche cui, vergognandocene un po’, può accadere di ricorrere quando non c’è altro cui aggrapparci o ogni altra soluzione parrebbe peggiore; e bisognerebbe, forse, parlare un po’ di più, parlare in modo più aderente alla realtà di questa eventualità anche nei libri e nei congressi.
Perché, forse, anche la regola per la quale al paziente bisogna sempre dire la verità, come quella per la quale non ci si deve fare coinvolgere emotivamente, alla luce dell’esperienza concreta, reale, mostra i suoi limiti. E – certo alla luce di un’autentica preoccupazione per la persona – anche il fatto di non ingannare mai non può essere (come ogni regola forse in fondo) assoluta.
Ma certo ogni eccezione deve essere considerata con la massima prudenza.
Uno dei pregi maggiori di questo libro, infatti, è raccontare il lavoro psichiatrico com’è. Con il suo fascino e i suoi dolori. Con le sue (poche) certezze e con i suoi dubbi. Con i suoi successi e con i suoi errori. Con le forzature, alle quali talvolta la realtà può costringere. Con i protocolli e le check list, utili a volte e a volte destinati ad apparire un po’ ridicoli e privi di senso. Con le sorprese, alle quali dobbiamo essere preparati: qualcuno che nonostante abbia tutti i sintomi della follia, è “normalmente” accettato così com’è dai suoi amici; qualcuno che cento volte non ce la fa a tornare a casa, e invece una volta ce la fa, e per rimanerci. Con la vicinanza, a tratti un sentimento che somiglia molto all’autentica amicizia; e la distanza, talvolta la contrapposizione dura alla quale si può essere costretti.
Il percorso fatto insieme da due viandanti insomma, nessuno dei quali sa con precisione dove quel percorso li conduca, come leggiamo.
Questo lavoro psichiatrico che a volte sembra così cambiato: prima di Basaglia, dopo Basaglia. Il tratto comune che lega le storie raccolte in questo volume è la consapevolezza, mi pare, che nella capacità di tollerare l’insicurezza, nella curiosità per l’essenza e la forma che le relazioni umane assumono in ognuna di esse sta oggi forse l’essenza più profonda di questo nostro lavoro.
Che a volte invece sembra così uguale a se stesso, arbitrario, supponente, a volte violento, uguale nei secoli: la rappresentazione impietosa della visita d’ingresso in manicomio da parte di un canonico genovese all’inizio del Novecento, descritta nel 1906 a Genova da Camillo Tomei; il dialogo tra due ricoverate nel 1928 in un film di successo, Changeling di Clint Eastwood (USA 2008); una scena come tante capita di vederne in una delle nostre corsie, descritta nel volume.
È un libro che racconta le case, e gli oggetti e le vite che le abitano. Case diverse l’una dall’altra, come sono diversi i mondi di coloro che le rendono vive. E racconta la strada, che sceglie con una scelta che desta scandalo chi una casa proprio non la vuole. La strada con i suoi rischi e i suoi pericoli, la strada con i suoi dubbi: «ci sono gli estremi per ricoverare una persona con la forza, se questa rifiuta di muoversi e rischia di morire per ipotermia? O piuttosto si viola la sua libertà di scelta, se decide di suicidarsi in questo modo piuttosto che in un altro? Il rifiuto è segno di malattia mentale o invece esprime una ribellione alle regole della società?».
O forse né l’uno né l’altro, aggiungerei, ed esprime qualcosa di più segreto, personale, privato?
Che cos’è insomma la libertà nel suo rapporto con la psichiatria, fino a che punto può arrivare, quale limite il principio di beneficialità può, e quale deve, farci imporre all’autonomia dell’altro? Quanto abbiamo diritto a esercitare quello che in fondo è uno degli sforzi maggiori, più defatiganti, che il lavoro psichiatrico impone: quando dobbiamo scegliere per l’altro, e quando invece possiamo sentirci liberi da questa responsabilità opprimente, e farne a meno.
Intervenire; o limitarci a monitorare la situazione per com’è, rispettarla. O accontentarci di cercare un compromesso, sperando che l’altro lo accetti.
Di fronte a queste esistenze sporche, malsane vissute sul ciglio della strada o in una catapecchia, o minate da un pericolo per il corpo o da forze emotive misteriose che come un elastico riportano al punto di partenza a un passo dal traguardo, la psichiatria incontra nella quotidianità i dilemmi centrali della bioetica. E con essi non deve stancarsi di confrontarsi.
A volte la follia meriterebbe di essere temporaneamente presa del tutto in carico, anche quando non vuole, per essere aiutata. Dove? Come? Bisognerebbe, gli autori hanno ragione, trovare sempre caso per caso la risposta più giusta a queste domande, quella più rispettosa dei bisogni, ma anche dei desideri, della persona. Quella che comunque preservi il massimo di libertà possibile. Ci vorrebbe molta attenzione, disporre di una gamma ampia di proposte da poter fare, perché i desideri (non solo i bisogni, anche i desideri) dell’altro trovino il più possibile accoglienza evitando al massimo vissuti di umiliazione, di oppressione, mentre le risposte a bisogni e desideri molto diversi caso per caso, sono in genere poche, seriali.
Così, in macchina con Carmine mentre si dirigono verso una “comunità” lo psichiatra si trova a riflettere su come possiamo a volte non renderci conto dell’enormità di quello che chiediamo al paziente; accettare, in un momento già in sé emotivamente più difficile, «una sistemazione che non gradisce, in un posto che non ha mai visto, con gente che non conosce». Sul fatto che le soluzioni che abbiamo da proporre sono spesso approssimative, inadeguate, richiedono sforzi a volte enormi di adattamento, impongono regole a volte tanto più vessatorie in quanto apparentemente prive di necessità (riguardanti ad esempio le visite, il telefono, il cibo, il fumo ecc.) e sono improntate a tutt’altro che alla libertà e all’accoglienza delle quali tanto parliamo. Piuttosto a una pedagogia spesso un po’ abborracciata.
Lo stesso caso di Carmine pone un'altra questione che fa riflettere. Per strada, capita che tratti con prepotenza un tabaccaio e in questo caso io (al contrario della voce narrante) mi sento più vicino emotivamente al tabaccaio, che a lui. È in scena la faccia cattiva della follia, che pure esiste perché la follia non è sempre vittima. È la faccia che mostra prepotenza e può diventare esplicita minaccia, anche violenza. Alla fine, il tabaccaio ha comprensibilmente paura e finisce col regalargli due pacchetti di sigarette, pur di sottrarsi alla scomoda situazione nella quale Carmine lo costringe. Mi viene da pensare che in molti SPDC questa scena sarebbe finita diversamente. Che forse il tabaccaio è più sfortunato, perché «l’arte di legare le persone», intesa come contenzione fisica dell’altro, o quella di sedare farmacologicamente, lui non le conosce e comunque non le può esercitare. Che quando la follia fa paura non si tratta solo di stigma; a volte – certo, a volte sì e a volte no, ed è nella generalizzazione che sta lo stigma – ci possono essere buone ragioni per averne paura. E coloro che ne hanno paura meritano anch’essi comprensione.
Le persone che ci vengono presentate, ciascuna con il suo mondo unico e singolare, spesso sanno e non sanno di essere matte, e a volte ci giocano un po’; sanno e non sanno di essere ingannate e forse a volte sanno che infondo va bene così, va bene non prendere coscienza ma lasciar fare perché in fondo sentono che chi li inganna lo fa perché vuole loro, e forse è tra i pochi, un po’ bene; sanno che chi cura può a volte commettere errori, ma il più delle volte sono disposte a perdonarci; nel loro incontro difficile con gli altri, a volte subiscono ingiustizie e violenze, ma a volte capita anche che le esercitino, un po’ come può capitare a tutti del resto.
A fare da collante tra i diversi mondi che ci vengono presentati e a raccontare qualcosa di più sul lavoro dello psichiatra nel territorio, ci sono i dialoghi in barca tra uno dei due autori e un amico curioso, una soluzione che mi è parsa particolarmente felice perché aiuta a dare informazioni indispensabili al lettore che “non è del giro”, senza però appesantire. Ed è alla voce dell’amico che dobbiamo, fin dalle prime pagine, l’identificazione di una possibile vocazione, credo comune a molti di noi, alla professione psichiatrica: essere stati, fin da giovani, avvocati delle cause perse.
Ci sono anche altri elementi di originalità che impreziosiscono sul piano della costruzione narrativa il volume, e meritano senz’altro un accenno. Come la scelta di porre il titolo di ciascuna storia, che ne esprime in certo senso la sintesi e la morale, in fondo al testo anziché al principio, forse per consentire in questo modo una lettura più libera dal condizionamento degli autori. O quella di offrire, al termine del volume, l’indice dei luoghi (davvero tanti, 50) nei quali le diverse vicende si svolgono, o quello degli animali e oggetti incontrati in quei luoghi, o delle emozioni e sentimenti che vi sono stati provati. O ancora (last and least, credo di indovinare) quello delle diverse diagnosi con le quali potrebbero essere indicati, rischiando però di perdere con questa riduzione tutto il resto che li arricchisce, questi cento mondi imperfetti.
Mondi imperfetti forse certo, ma mondi ai quali gli autori si avvicinano con la curiosità, il rispetto, il garbo e, spesso, l’affetto (Binswanger direbbe forse l'amicizia) con i quali credo che chiedano anche a noi lettori di avvicinarci ad essi, a nostra volta.
Le undici storie raccolte da Paolella nell’archivio del San Lazzaro, insomma, mi pare che testimonino nel loro insieme come in manicomio si potesse entrare da tante porte, a partire da vicende di vita, molto diverse l’una dall’altra. E come si potesse trovare la porta dell’uscita dopo un tempo relativamente breve o dopo un tempo lungo, a volte lunghissimo. Come si potesse uscire, per poi ritornare; oppure no.
Costituiscono uno spaccato che gli consente, attraverso lo stile narrativo piacevole della scrittura di microbiografie, di gettare una luce su cos’era la psichiatria in quei decenni a cavallo tra Otto e Novecento; una psichiatria che non si presenta, in queste pagine, negli aspetti più drammatici o più tragici che della vicenda del manicomio certo sono una parte importante, ma che appare qui impegnata in un’attività curiosa di identificazione e di studio di quel qualcosa di “strano”, di ”anormale” che costituisce la follia nell’infinita varietà delle sue possibili declinazioni.
Una psichiatria curiosa, per riprendere il dilemma che Sergio Zavoli pose a Franco Basaglia in una nota intervista televisiva (vai al link), decisamente più interessata alla malattia – alla sua osservazione e alla spiegazione, ove possibile, delle sue cause – che al malato.
Siamo cioè in questi casi ancora all’interno, almeno a valutare dalle tracce che i documenti hanno tramandato, di quella «riduzione obiettivante del paziente psichiatrico a cui approda la neuropsichiatria nel suo affermarsi (a cavallo tra ‘800 e ‘900) e che comporta la esclusione della significanza semeiologica delle emozioni e sentimenti che il paziente possa suscitare nell’esaminatore» alla quale Luciano Del Pistoia fa correlativamente riferimento nel saggio del quale già si è detto.
E, insieme a uno spaccato di quella psichiatria, offrono anche uno spaccato di com’era, in quegli anni, l’Italia: la sua borghesia e la relativa ricerca, anche attraverso l’esclusione psichiatrica, di una tranquillizzante, e forse un po’ ipocrita e a volte un po’ crudele, normalità.
 Tutt’altra psichiatria è quella della quale si occupa il secondo volume che consideriamo – CIM. Cento imperfetti mondi – che è anch’esso una raccolta di storie, o più precisamente dovrei scrivere di incontri, esplorazioni del mondo che l’altro, caso per caso, costituisce. E in questo si coglie una differenza importante tra le psichiatrie che sono oggetto dei due volumi: da un lato la psichiatria positivista e la storia del paziente come mero oggetto di osservazione dello psichiatra, che s’imbatte in un’esistenza, la descrive, la studia, ma non entra in relazione con essa, o almeno non lascia traccia, nel documentare la vicenda, di questa relazione. Lo psichiatra descrive, ed è fuori scena. Dall’altro lato, la psichiatria dei nostri servizi, alla quale la psicoanalisi e la fenomenologia hanno insegnato a fare delle risonanze che evoca nell’osservatore l’incontro con l’altro, la luce per può permettere di cogliere, e in qualche misura arrivare a volte a comprendere, il suo particolare (forse imperfetto, certo) mondo, per poi raccontarlo attraverso il filtro dell’esperienza che se ne è fatta.
Tutt’altra psichiatria è quella della quale si occupa il secondo volume che consideriamo – CIM. Cento imperfetti mondi – che è anch’esso una raccolta di storie, o più precisamente dovrei scrivere di incontri, esplorazioni del mondo che l’altro, caso per caso, costituisce. E in questo si coglie una differenza importante tra le psichiatrie che sono oggetto dei due volumi: da un lato la psichiatria positivista e la storia del paziente come mero oggetto di osservazione dello psichiatra, che s’imbatte in un’esistenza, la descrive, la studia, ma non entra in relazione con essa, o almeno non lascia traccia, nel documentare la vicenda, di questa relazione. Lo psichiatra descrive, ed è fuori scena. Dall’altro lato, la psichiatria dei nostri servizi, alla quale la psicoanalisi e la fenomenologia hanno insegnato a fare delle risonanze che evoca nell’osservatore l’incontro con l’altro, la luce per può permettere di cogliere, e in qualche misura arrivare a volte a comprendere, il suo particolare (forse imperfetto, certo) mondo, per poi raccontarlo attraverso il filtro dell’esperienza che se ne è fatta.Certo la psichiatria è cambiata, non foss’altro per questo; ma poi anche per i luoghi del suo svolgersi, che dal manicomio sono adesso i luoghi più vari, e a volte più strani, nei quali si svolge la vita reale (al termine del volume ne sono elencati una cinquantina). E poi certo per molto altro, nel secolo che separa tra loro le 100 vicende oggetto di questo secondo volume dalle 11 oggetto del primo.
Ma, accanto a cose che cambiano, ci sono anche cose che ritornano: come quando la psichiatra è chiamata a intervenire nei nostri anni nel corso di una crisi mistica nella cattedrale e al leggerne perdiamo il senso del tempo: non sappiamo più se la scena si svolge nel madioevo quando la cattedrale è stata costruita con le sue allegorie marmoree allora certo più evocative di oggi, nell’Ottocento di Paolella o nell’oggi in cui si muovono Buscaglia e Pezzoni.
Il sacro, evidentemente, è tra i dilemmi che l’uomo porta attraverso il tempo con sé; e in ogni tempo può evocare risposte imperfette, e sfidare alla loro lettura.
Narrare storie, le storie diverse che ieri portavano al manicomio e oggi portano alla chiamata al CIM, è un’operazione nella quale i due autori di CIM, voltandosi indietro subito dopo essere andati in pensione, si cimentano in questo caso cento volte. Cento mondi diversi, appunto, incontrati nel corso delle loro carriere: lui di psichiatra di campagna e di mare, avendo esercitato soprattutto nella zona delle cittadine rivierasche di ponente della provincia di Savona e del loro entroterra, lei psichiatra urbana, avendo esercitato – dopo un breve passaggio anche lei per il Savonese – soprattutto a Genova, nella zona del Centro storico.
Buscaglia e Pezzoni hanno fatto a tempo a vedere nei loro primi anni di lavoro, ancora il manicomio, dove andavano a conoscere i pazienti prossimi alla dimissione. Ma operano in una psichiatria che si è lasciata il manicomio alle spalle. Toccano a volte l’ospedale, il mondo della corsia «con una guardiola al centro per gli infermieri, le stanze dei medici dove si fa il caffè, gli scaffali per le cartelle, l’arrivo dei consulenti, gli elettrocadiogrammi, le rivalità al coltello tra i medici strutturati che, in realtà, sono la vera attività clinica di tutti i reparti (…). I pazienti sono in pigiama, i sanitari in camice. Tutto va avanti con un suo ritmo, in fondo rassicurante: il giro al mattino, le ore vuote al pomeriggio».
Ma il loro lavoro si svolge prevalentemente nel territorio, nei luoghi vari e strani della vita vera delle persone, e scrivono a un certo punto: «mi sembra che ci sia un abisso tra osservare le persone nel loro ambiente naturale e vederle chiuse in gabbia come allo zoo».
Hanno vissuto il tempo nel quale, prima della metà degli anni ’90, i CSM in Liguria curavano sia i disturbi psichiatrici intesi in senso stretto che la tossicodipendenza.
Sul piano dell’attività letteraria, costituiscono ormai una coppia affiatata: nel 2004 hanno dato alle stampe Parlare di follia. Esperienze di vita quotidana nella pratica psichiatrica (De Ferrari), nel 2018 si sono cimentati con la narrativa, nella quale entrambi si erano già sperimentati individualmente, con il noir L’artiglio del grifone (Araba Fenice).
CIM – centro di igiene mentale – è la denominazione dei primi embrioni di servizi psichiatrici diffusi sul territorio negli anni ’60, ed è rimasta la sigla con la quale, soprattutto in provincia di Savona dove ad essa tutti – operatori, utenti ecc. – paiono affettivamente legati, ci si riferisce ancora oggi nel linguaggio corrente ai CSM (Centri di Salute Mentale).
Non potrò, con questa recensione, certo riproporre ciascuno dei cento mondi sui quali gli autori ci permettono di affacciarci. Né potrò certo fare assaggiare il pregio letterario della loro narrazione che ne costituisce, per Paolo Milone che è autore della prefazione, l’aspetto più importante da considerare. Mi limiterò, quindi, a trarre spunto da qualcuna di queste storie per cogliere gli aspetti più critici del lavoro degli autori, nel quale riconosco fortemente il mio come credo che potranno fare altri.
Certo sono relazioni strane, queste che si stabiliscono nell’attività del CIM. Relazioni che hanno a che fare con il lavoro (il lavoro d’aiuto), ma inevitabilmente anche con la vita. E giustamente commentano gli autori: «la prima cosa che si insegna a un operatore è di non farsi coinvolgere, di non confondere il piano professionale con quello personale». Ma lo scrivono per dire subito dopo che non è facile, e forse neppure è proprio possibile, mantenere fermo il limite quando una relazione si prolunga negli anni, quando le emozioni che passano tra i due che ne sono protagonisti sono di quelle più intense.
Nel territorio, più che nell’ospedale dove le relazioni sono più brevi, l’istituzione è più incombente e le difese a salvaguardia del setting sono più rigide, le relazioni che tendono a stabilirsi non possono davvero a volte prescindere da una dimensione personale, che ha a che fare con l’autentica vita. È così ad esempio quando un’infermiera piange perché Paolo è morto improvvisamente d’infarto, e uno degli autori commenta: «Sono orgoglioso di lei e del suo cuore grande, capace di curare più di qualsiasi medicina». O quando l’altro autore si imbatte sulla strada in storie commuoventi che hanno a che fare con emozioni che sono comuni a ogni persona, da una parte o dall’altra del setting, e può così capitare che una lacrima, di nascosto, «sciolga il mascara».
La vicenda di Paolo ci introduce anche a un tema delicato, del quale si parla di rado: l’uso dell’inganno per curare, che in questo testo ricorre in due occasioni. Quella stessa infermiera confessa infatti al medico di avere in un’occasione ingannato il paziente, sfruttando la sua buona fede e il suo delirio, quando si era trattato di ottenere la sua firma in calce alla domanda per la pensione d’invalidità. È una questione che ritorna oltre, nel caso di Giobatta che non vuole più mangiare né bere e viene convinto a farlo, facendo leva sulla logica stessa del suo delirio.
Non c’erano ancora la Legge 180 e la psichiatria nel territorio, anzi non c’era proprio ancora la psichiatria, quando un sacerdote generoso e dotato di senso pratico, padre Antero Maria Micone, si trovava a metà del ‘600, in piena peste, a dirigere il lazzaretto genovese della Consolazione. Gli posero lo stesso problema nel quale si trova in tutt’altro contesto il giovane psichiatra di Giobatta: convincere un uomo con delirio di avvelenamento a cibarsi, perché non muoia di fame. E la soluzione che trovò allora fu la stessa: ingannare il paziente, manipolando la logica del suo delirio. Una tattica uguale, del resto, utilizzavano in quegli stessi anni gli amici di don Chisciotte al termine del primo volume, per riportarlo a casa.
Si tratta di situazioni, a quattro secoli di distanza, nelle quali rendere il delirio compatibile con la sopravvivenza viene considerato più importante che imporre alla falsa verità del delirio la vera verità. Tattiche cui, vergognandocene un po’, può accadere di ricorrere quando non c’è altro cui aggrapparci o ogni altra soluzione parrebbe peggiore; e bisognerebbe, forse, parlare un po’ di più, parlare in modo più aderente alla realtà di questa eventualità anche nei libri e nei congressi.
Perché, forse, anche la regola per la quale al paziente bisogna sempre dire la verità, come quella per la quale non ci si deve fare coinvolgere emotivamente, alla luce dell’esperienza concreta, reale, mostra i suoi limiti. E – certo alla luce di un’autentica preoccupazione per la persona – anche il fatto di non ingannare mai non può essere (come ogni regola forse in fondo) assoluta.
Ma certo ogni eccezione deve essere considerata con la massima prudenza.
Uno dei pregi maggiori di questo libro, infatti, è raccontare il lavoro psichiatrico com’è. Con il suo fascino e i suoi dolori. Con le sue (poche) certezze e con i suoi dubbi. Con i suoi successi e con i suoi errori. Con le forzature, alle quali talvolta la realtà può costringere. Con i protocolli e le check list, utili a volte e a volte destinati ad apparire un po’ ridicoli e privi di senso. Con le sorprese, alle quali dobbiamo essere preparati: qualcuno che nonostante abbia tutti i sintomi della follia, è “normalmente” accettato così com’è dai suoi amici; qualcuno che cento volte non ce la fa a tornare a casa, e invece una volta ce la fa, e per rimanerci. Con la vicinanza, a tratti un sentimento che somiglia molto all’autentica amicizia; e la distanza, talvolta la contrapposizione dura alla quale si può essere costretti.
Il percorso fatto insieme da due viandanti insomma, nessuno dei quali sa con precisione dove quel percorso li conduca, come leggiamo.
Questo lavoro psichiatrico che a volte sembra così cambiato: prima di Basaglia, dopo Basaglia. Il tratto comune che lega le storie raccolte in questo volume è la consapevolezza, mi pare, che nella capacità di tollerare l’insicurezza, nella curiosità per l’essenza e la forma che le relazioni umane assumono in ognuna di esse sta oggi forse l’essenza più profonda di questo nostro lavoro.
Che a volte invece sembra così uguale a se stesso, arbitrario, supponente, a volte violento, uguale nei secoli: la rappresentazione impietosa della visita d’ingresso in manicomio da parte di un canonico genovese all’inizio del Novecento, descritta nel 1906 a Genova da Camillo Tomei; il dialogo tra due ricoverate nel 1928 in un film di successo, Changeling di Clint Eastwood (USA 2008); una scena come tante capita di vederne in una delle nostre corsie, descritta nel volume.
È un libro che racconta le case, e gli oggetti e le vite che le abitano. Case diverse l’una dall’altra, come sono diversi i mondi di coloro che le rendono vive. E racconta la strada, che sceglie con una scelta che desta scandalo chi una casa proprio non la vuole. La strada con i suoi rischi e i suoi pericoli, la strada con i suoi dubbi: «ci sono gli estremi per ricoverare una persona con la forza, se questa rifiuta di muoversi e rischia di morire per ipotermia? O piuttosto si viola la sua libertà di scelta, se decide di suicidarsi in questo modo piuttosto che in un altro? Il rifiuto è segno di malattia mentale o invece esprime una ribellione alle regole della società?».
O forse né l’uno né l’altro, aggiungerei, ed esprime qualcosa di più segreto, personale, privato?
Che cos’è insomma la libertà nel suo rapporto con la psichiatria, fino a che punto può arrivare, quale limite il principio di beneficialità può, e quale deve, farci imporre all’autonomia dell’altro? Quanto abbiamo diritto a esercitare quello che in fondo è uno degli sforzi maggiori, più defatiganti, che il lavoro psichiatrico impone: quando dobbiamo scegliere per l’altro, e quando invece possiamo sentirci liberi da questa responsabilità opprimente, e farne a meno.
Intervenire; o limitarci a monitorare la situazione per com’è, rispettarla. O accontentarci di cercare un compromesso, sperando che l’altro lo accetti.
Di fronte a queste esistenze sporche, malsane vissute sul ciglio della strada o in una catapecchia, o minate da un pericolo per il corpo o da forze emotive misteriose che come un elastico riportano al punto di partenza a un passo dal traguardo, la psichiatria incontra nella quotidianità i dilemmi centrali della bioetica. E con essi non deve stancarsi di confrontarsi.
A volte la follia meriterebbe di essere temporaneamente presa del tutto in carico, anche quando non vuole, per essere aiutata. Dove? Come? Bisognerebbe, gli autori hanno ragione, trovare sempre caso per caso la risposta più giusta a queste domande, quella più rispettosa dei bisogni, ma anche dei desideri, della persona. Quella che comunque preservi il massimo di libertà possibile. Ci vorrebbe molta attenzione, disporre di una gamma ampia di proposte da poter fare, perché i desideri (non solo i bisogni, anche i desideri) dell’altro trovino il più possibile accoglienza evitando al massimo vissuti di umiliazione, di oppressione, mentre le risposte a bisogni e desideri molto diversi caso per caso, sono in genere poche, seriali.
Così, in macchina con Carmine mentre si dirigono verso una “comunità” lo psichiatra si trova a riflettere su come possiamo a volte non renderci conto dell’enormità di quello che chiediamo al paziente; accettare, in un momento già in sé emotivamente più difficile, «una sistemazione che non gradisce, in un posto che non ha mai visto, con gente che non conosce». Sul fatto che le soluzioni che abbiamo da proporre sono spesso approssimative, inadeguate, richiedono sforzi a volte enormi di adattamento, impongono regole a volte tanto più vessatorie in quanto apparentemente prive di necessità (riguardanti ad esempio le visite, il telefono, il cibo, il fumo ecc.) e sono improntate a tutt’altro che alla libertà e all’accoglienza delle quali tanto parliamo. Piuttosto a una pedagogia spesso un po’ abborracciata.
Lo stesso caso di Carmine pone un'altra questione che fa riflettere. Per strada, capita che tratti con prepotenza un tabaccaio e in questo caso io (al contrario della voce narrante) mi sento più vicino emotivamente al tabaccaio, che a lui. È in scena la faccia cattiva della follia, che pure esiste perché la follia non è sempre vittima. È la faccia che mostra prepotenza e può diventare esplicita minaccia, anche violenza. Alla fine, il tabaccaio ha comprensibilmente paura e finisce col regalargli due pacchetti di sigarette, pur di sottrarsi alla scomoda situazione nella quale Carmine lo costringe. Mi viene da pensare che in molti SPDC questa scena sarebbe finita diversamente. Che forse il tabaccaio è più sfortunato, perché «l’arte di legare le persone», intesa come contenzione fisica dell’altro, o quella di sedare farmacologicamente, lui non le conosce e comunque non le può esercitare. Che quando la follia fa paura non si tratta solo di stigma; a volte – certo, a volte sì e a volte no, ed è nella generalizzazione che sta lo stigma – ci possono essere buone ragioni per averne paura. E coloro che ne hanno paura meritano anch’essi comprensione.
Le persone che ci vengono presentate, ciascuna con il suo mondo unico e singolare, spesso sanno e non sanno di essere matte, e a volte ci giocano un po’; sanno e non sanno di essere ingannate e forse a volte sanno che infondo va bene così, va bene non prendere coscienza ma lasciar fare perché in fondo sentono che chi li inganna lo fa perché vuole loro, e forse è tra i pochi, un po’ bene; sanno che chi cura può a volte commettere errori, ma il più delle volte sono disposte a perdonarci; nel loro incontro difficile con gli altri, a volte subiscono ingiustizie e violenze, ma a volte capita anche che le esercitino, un po’ come può capitare a tutti del resto.
A fare da collante tra i diversi mondi che ci vengono presentati e a raccontare qualcosa di più sul lavoro dello psichiatra nel territorio, ci sono i dialoghi in barca tra uno dei due autori e un amico curioso, una soluzione che mi è parsa particolarmente felice perché aiuta a dare informazioni indispensabili al lettore che “non è del giro”, senza però appesantire. Ed è alla voce dell’amico che dobbiamo, fin dalle prime pagine, l’identificazione di una possibile vocazione, credo comune a molti di noi, alla professione psichiatrica: essere stati, fin da giovani, avvocati delle cause perse.
Ci sono anche altri elementi di originalità che impreziosiscono sul piano della costruzione narrativa il volume, e meritano senz’altro un accenno. Come la scelta di porre il titolo di ciascuna storia, che ne esprime in certo senso la sintesi e la morale, in fondo al testo anziché al principio, forse per consentire in questo modo una lettura più libera dal condizionamento degli autori. O quella di offrire, al termine del volume, l’indice dei luoghi (davvero tanti, 50) nei quali le diverse vicende si svolgono, o quello degli animali e oggetti incontrati in quei luoghi, o delle emozioni e sentimenti che vi sono stati provati. O ancora (last and least, credo di indovinare) quello delle diverse diagnosi con le quali potrebbero essere indicati, rischiando però di perdere con questa riduzione tutto il resto che li arricchisce, questi cento mondi imperfetti.
Mondi imperfetti forse certo, ma mondi ai quali gli autori si avvicinano con la curiosità, il rispetto, il garbo e, spesso, l’affetto (Binswanger direbbe forse l'amicizia) con i quali credo che chiedano anche a noi lettori di avvicinarci ad essi, a nostra volta.
![]()








0 commenti