Si è spento il 6 luglio 2021 il giornalista, storico e scrittore Angelo Del Boca; era nato a Novara il 23 maggio 1925. Prima nel 1963, con il volume La scelta (Feltrinelli), e poi nel 2020 con il volume curato da Mimmo Franzinelli Nella notte ci guidano le stelle. La mia storia partigiana (GEDI), aveva pubblicato i suoi ricordi di partigiano.
Parte I: Un libro-inchiesta sull’Ospedale Psichiatrico in Italia a metà anni ‘60
Nel 1966 Del Boca aveva pubblicato per la collana “I radar” delle Edizioni Dell’Albero di Torino il volume Manicomi come lager. Centomila ostaggi da liberare. Una legge iniqua, e mi pare che possiamo iniziare dal contributo importante che ha dato al miglioramento della psichiatria italiana, un contributo del resto che gli è ampiamente riconosciuto dalla storica Valeria Paola Babini nel tracciare la storia della nostra psichiatria nel corso del Novecento (Liberi tutti, Il mulino, 2009).
Sulla copertina una frase di Georges Daumézon, uno dei maestri della psicoterapia istituzionale in Francia tra gli anni ’40 e ’60, che oggi, di fronte alle discussioni cui ha dato luogo la II Conferenza nazionale sulla relazione tra “psichiatria” e “salute mentale di comunità”, non può non sembrare illuminante: «Il medico può combattere la malattia, solo la società può combattere l’alienazione».
Questa è del resto la posizione di Del Boca, che rivolge il suo libro-inchiesta per informare sulle cose della psichiatria e degli Ospedali Psichiatrici (OP) l’opinione pubblica, e la politica che in quel momento si trovava di fronte alla necesità di scelte importanti al riguardo.
L’intento è fin dalla breve premessa quello della denuncia della condizione degli OP italiani in quel momento, ed è già interessante scorrere la serie dei ringraziamenti. Manca Basaglia, perché evidentemente due anni prima de L’istituzione negata il suo lavoro a Gorizia non era ancora così noto, anche se poi è ricordato nel testo a p. 34 («Un esperimento ancora più di rilievo è quello in atto all’O.P. di Gorizia, sotto la direzione del prof. F. Basaglia. A Gorizia non ci si è accontentati di costituire un reparto “aperto”, ma si è voluto etendere questo regime a tutto l’ospedale (…) così da realizzare sulle sue ceneri una “Comunità Terapeutica”»).
 Sono invece presenti Edoardo Balduzzi, propugnatore per l’Italia della “psichiatria di settore” e Mario Tobino cui Del Boca si riferisce come a un amico personale e apprezza l’impronta umanitaria dei romanzi, che anni dopo avrebbe assunto una posizione nostalgica e conservatrice rispetto all’OP. C’è anche Giorgio Coda, lo psichiatra di Torino che anni dopo sarebbe stato al centro di una vicenda giudiziaria per comportamenti sadici verso pazienti adulti e bambini.
Sono invece presenti Edoardo Balduzzi, propugnatore per l’Italia della “psichiatria di settore” e Mario Tobino cui Del Boca si riferisce come a un amico personale e apprezza l’impronta umanitaria dei romanzi, che anni dopo avrebbe assunto una posizione nostalgica e conservatrice rispetto all’OP. C’è anche Giorgio Coda, lo psichiatra di Torino che anni dopo sarebbe stato al centro di una vicenda giudiziaria per comportamenti sadici verso pazienti adulti e bambini.
Quanto al libro, si apre con la nota frase, pronunciata il 20 settembre 1965, con la quale il ministro della sanità Luigi Mariotti paragonò gli ospedali psichiatrici a “veri e propri lager germanici” e a “bolge dantesche”. A queste affermazioni – ed è bene rileggerlo perché c’è sempre il rischio che alla ricostruzione storica poi tutti possano sembrare dalla parte “giusta” fin da subito – reagirono offese l’AMOPI, forte di 800 iscritti, con il suo presidente Ferdinando Barison e la SIP con il suo presidente Mario Gozzano, che considerarono sostanzialmente infondate e frutto di generalizzazione e superficialità le critiche alla situazione da parte di Mariotti. L’inchiesta condotta dal ministero già nel 1962 e il Libro bianco pubblicato nel 1965 avevano messo in luce carenze drammatiche nel numero dei posti letto, dell’ampiezza degli edifici, nel personale. Due psichiatri di quegli anni, il prof. Aschieri di Varese e Max Beluffi di Mombello danno della condizione degli ospedali psichiatrici una rappresentazione drammatica. I successivi capitoli documentano le condizioni di questi luoghi, che ricordano “più il carcere che l’ospedale”, le modalità d’ingresso con il sequestro di ogni oggetto personale e la vestizione di un’uniforme spesso sgualcita e fuori taglia. Nelle parole di un internato e in quelle dello psichiatra Giorgio Ceccarelli di Genova questi riti di iniziazione aprono il processo di umiliazione e inferiorizzazione, che fu reso celebre in quegli anni dai libri di Goffmann e di Basaglia. La visita dell’ospedale di via Giulio a Torino, dove colpisce il sovraffollamento e «lo spettacolo di desolazione e di inedia è deprimente, ma è nulla al confronto di quello che il manicomio offre d’inverno, quando tutte le malate sono costrette in camerata». Le camerate sono immense, fetide a volte, l’atmosfera di carcere e lazzaretto ricorda gli ambienti descritti da Dickens. Né vale il comodo alibi per il quale dopo i primi tempi di internamento gli psicotici diventerebbero insensibili alle modalità con le quali sono trattati. A Collegno gli spazi sono più ampi, è più presente l’ergoterapia ma questo non basta a migliorare molto le cose. A Lucca, in compagnia di Tobino, Del Boca incontra una situazione un po’ migliore, ma solo per quanto gli consente il contesto a partire dalle dimensioni delle camerate. Né va meglio in due ospedali più recenti – il Santa Maria della Pietà di Roma e il Savonera presso Torino. Le stesse dimensioni spersonalizzanti, la stessa sciatteria. Il reparto delle sudice di Savonera ospita ottanta donne in tre camerate, tra i 19 e i 94 anni «ma non c’è più età su questi volti che il sole non sfiora da mesi o da anni; non cè più pudore questi sguardi abituati alla più avvilente promiscuità; non c’è più speranza in questi occhi che hanno come unico spettacolo il rapido muoversi delle labbra delle confabulatrici, l’agitarsi delle contenute, il volto scarno e devastato delle più vecchie, ridotte a larve […]. Sono in gran parte legate con le cinghie di contenzione». Bolge dantesche, insomma!
Certo, alcune rare situazioni appaiono a Del Boca migliori, perché qualche passo avanti è stato fatto in direzione della personalizzazione della cura. È il caso di Varese, costruito da Fiamberti e diretto in quel momento da Edoardo Balduzzi. O quello del Chiarugi (San Salvi) di Firenze, o situazioni più limitate, come “Villa Verde” e “Villa Azzurra”, destinato ai ragazzi (che sarebbe poi stata al centro, però, del processo Coda), a Torino, “Villa Donato” a Bologna, o la Gorizia di Basaglia.
Un capitolo è dedicato al personale, scarso e malpagato e, per quanto riguarda gli infermieri – che si sentono «manovali della pazzia» – per nulla formato, ma complessivamente fortemente bisognoso di riqualificazione. Pressocché ignorati sono il lavoro d’équipe, la riflessione psicoanalitica sulle relazioni di cura, applicata senza reali obiettivi di cura l’ergoterapia. Questa la situazione nella maggior parte degli ospedali psichiatrici. Ancora peggiore fuori, dove i Centri di Igiene Mentale sono pochissimi, ancora meno gli ospedali diurni, scarso l’interesse per la psichiatria di settore.
Quanto agli orientamenti degli psichiatri, il professor Benvenuti li aveva sintetizzati in quel periodo così: «ci sono gli ospedalisti e gli antiospedalisti; ci sono i settorialisti e gli antisettorialisti; ci sono quelli che prevedono e auspicano reparti psichiatrici negli ospedali civili e quelli che non vogliono questo».
Dopo una lunga digressione sulla situazione in Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti (sono gli stessi riferimenti che utilizza Basaglia in quegli anni, ed erano evidentemente i più interessanti), il libro-inchiesta si concentra sulla “riforma Mariotti” per come si presentava in quella fase della discussione, che durava già da dieci anni: sostituzione dell’iscrizione al Casellario Giudiziario dei ricoverati definitivi in manicomio introdotta con il Codice di Procedura Penale dal regime fascista a peggiorare la legge del 1904, con l’istituzione di una “Anagrafe psichiatrica” limitata ai casi ritenuti pericolosi; tetto massimo di posti letto negli ospedali a 500 e massiccio incremento degli organici; forte incremento dei servizi extraospedalieri; previsioni per il reinserimento lavorativo dei dimessi dall’OP. Del Boca riporta le critiche dell’AMOPI, che consistevano nel rifiuto schedatura dei malati anche nella forma edulcorata che era proposta; nella contrarietà alla separazione tra OP e servizi extraospedalieri prevista dal legislatore, opposta al modello del settore sposato in quegli anni anche dall’OMS (e già allora contestato da alcuni per il rischio di una «psichiatrizzazione dell’intera società»); nella richiesta che non si ignorasse la questione delle Opere Pie, forti in quel momento di 35.000 posti letto; nel fatto di cogliere nella proposta di trasferire gli internati tranquilli in istituti a carattere più assistenziale rispetto all’OP, l’abbandono di fatto di ogni prospettiva di reinserimento per quello che li riguardava. E su quest’ultimo punto mi hanno colpito le parole del prof. Garavaglia, per l’assonanza con quelle che ho sempre sentito da parte di Antonio Slavich, in quel caso a proposito dei degenti che erano rimasti negli ex-OP dopo la legge 180: «Questi vecchi malati (…) in parte sono la testimonianza della nostra inefficienza. (…). Della stratificazione di incompetenze, di negligenze, di pigrizie, di sonnolenze. Devono rrimanere nel nostro ospedale a ricordarci che noi non dobbiamo più essere così. Altro che eliminarli! Se noi li eliminiamo allontanandoli, facciamo come colui che elimina il senso di colpa e continua a fare il delinquente». Del Boca riporta poi anche i contenuti del progetto di 23 deputati di PCI e PSIUP a prima firma Marcella Balconi, che appare più avanzato rispetto a quello ministeriale: nessuna schedatura psichiatrica, tetto di posti letto per gli OP a 500, organizzazione a settore polarizzata sui servizi esterni diurni e notturni, con l’istituzione tra l’altro di un servizio per adulti e uno per minori per ogni area di 70-100.000 abitanti, forti tra tutti di non meno di 5.000 medici.
Nessuno insomma, mi pare evidente, pensava in quel momento alla possibilità di lasciarsi del tutto l’OP alle spalle, cui Basaglia aveva già fatto riferimento due anni prima a Londra; non c’è da stupirsi né da perdersi in minuzie perciò, credo, se la legge che dodici anni dopo ha chiuso gli OP viene ovviamente chiamata da tutti: “Legge Basaglia”!
Nell’intervista che rilascia a Del Boca e chiude il volume, il ministro insiste sullo stretto collegamento tra riforma degli OP e riforma ospedaliera; rivendica il carattere e la gestione solo sanitari della prevista “Anagrafe psichiatrica”, e manifesta comunque disponibilità a ridicutere questo come altri aspetti; rivendica il carattere rivoluzionario della riorganizzazione degli OP (dei quali è però previsto un potenziamento) e l’introduzione, tra l’altro, nel loro organico dello psicologo, e poi quello dell’istituzione dei CIM, dei centri diurni e notturni, del lavoro protetto.
Nel suo commento, l’autore auspica che effettivamente alcuni ritocchi possano essere effettuati al progetto Mariotti, ma paventa anche il rischio di un anacquamento, o di nuovi rinvii. Infine, auspica l’inizio di quella che oggi definiremmo un’ampia campagna di lotta allo stigma a partire dalle scuole e dal moltiplicarsi di iniziative come quella della nascita a Firenze dell’Associazione per la lotta contro le malattie mentali, che tanta parte avrebbe avuto nel dibattito degli anni successivi, e come quella delle iniziative che si vanno moltiplicandosi in quel momento per ripristinare il contatto tra società e internati attraverso, in particolare, l’organizzazione di iniziative a carattere culturale e artistico. E conclude: «Ciò che dobbiamo raggiungere è il convincimento che non esistono due diverse società, quella della gente “normale” e l’altra, ingiustamente segregata, dei malati di mente; e che la rivoluzione in atto in psichiatria non sarà mai completa se, come ha scritto Tobino, non interverrà l’aiuto “da uomo a uomo”, quell’atto che è indispensabile perché tanti infelici possano passare “dalle nebbie alla luce”».
Completano il testo tre appendici: la relazione di presentazionme e il contenuto del disegno di legge Mariotti; l’intervento di Edoardo Balduzzi al congresso di Varese del marzo 1965 in favore del modello della psichiatria di settore; un articolo scritto da Mario Tobino rispetto alla costruzione del nuovo OP di Vicenza, in favore dell’umanizzazione degli OP.
Parte II: Perché gli italiani non sono brava gente
Del Boca però non è noto al grande pubblico per il suo contributo critico alla psichiatria. Per un altro illustre storico del colonialismo italiano, infatti: «oggi si ricordano solo i gas di Mussolini, Italiani brava gente, le polemiche… ma si dimentica che tutto ciò era basato su sei straordinari volumi di ricerca editi tra gli anni Settanta e Ottanta che hanno, cambiato la conoscenza del colonialismo italiano».
Nicola Labanca allude qui evidentemente a volumi come Gli italiani in Africa orientale (Laterza, 1982), Ras Immiru, aristocratico e guerriero (Loescher, 1985), Gli italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi (Mondadori, 1994), Gheddafi: una sfida dal deserto (Laterza, 1998), A un passo dalla forca: atrocità e infamie dell’occupazione italiana della Libia nelle memorie del patriota Mohamed Fekini (Mondolibri, 2007), Il Negus. Vita e morte dell’ultimo Re dei Re (Laterza, 2007), La guerra d’Etiopia: l’ultima impresa del colonialismo (RCS, 2020).
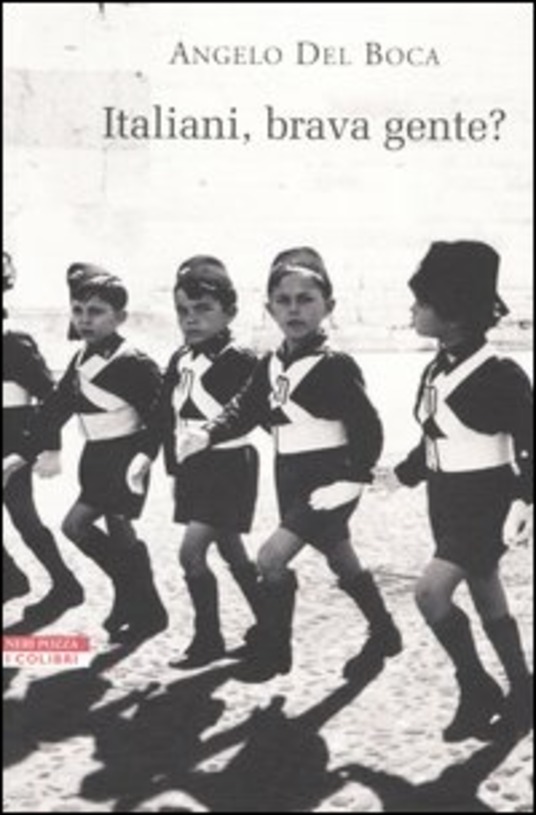 Tra questi volumi vorrei proporre qui la rilettura di quello più noto al pubblico non specialistico, che rappresenta anche una sorta di sintesi degli altri e che con un titolo particolarmente efficace è diventato il simbolo di un modo diverso, opposto – meno retorico e più onesto cioè – di considerare la storia italiana contemporanea: Italiani, brava gente? Un mito duro a morire (Neri Pozza, 2004).
Tra questi volumi vorrei proporre qui la rilettura di quello più noto al pubblico non specialistico, che rappresenta anche una sorta di sintesi degli altri e che con un titolo particolarmente efficace è diventato il simbolo di un modo diverso, opposto – meno retorico e più onesto cioè – di considerare la storia italiana contemporanea: Italiani, brava gente? Un mito duro a morire (Neri Pozza, 2004).
I primi con i quali gli italiani se la presero a Italia da poco unita furono, nella ricostruzione di Del Boca, gli italiani stessi. Chi ha dipinto il Risorgimento come anelito unitario unanime da tutta la penisola ha forse tralasciato di ricordare tra tanti altri momenti le stragi di Pontelandolfo e Casalbuti, due paesi del Sannio che il 15 agosto 1861 subirono dall’esercito sabaudo lo stesso trattamento che neppure un secolo dopo Boves subì da parte dell’occupante tedesco. Il che seguiva, del resto, altre pagine vergognose, come la macchia più vistosa dell’epopea garibaldina costituita dall’eccidio ordinato da Nino Bixio a Bronte, nell’agosto 1860.
La prima impresa dell’Italia all’estero sulla quale Del Boca si sofferma è invece la partecipazione, con le altre potenze coloniali, alla repressione della rivolta dei boxer in Cina; tutt’altro che un’impresa civilizzatrice come sosteneva la propaganda, ma una violenta aggressione imperialista nelle parole degli stessi ufficiali italiani.
Siamo al 1911 quando l‘Italia decide di occupare, senza nessuna plausibile giustificazione se non avere la propria parte della rapina coloniale, la Libia. A una strage di soldati italiani compiuta dai turchi affiancati dai ribelli arabi di Tripoli e dell’oasi di Sciara Sciat, gli occupanti italiani reagivano massacrando in una rappresaglia tra 1000 e 4000 arabi, in gran parte civili del tutto estranei ai fatti. Altrettanti, che variano a seconda delle stime, erano deportati nelle piccole isole del sud Italia e ivi rimasero a lungo esiliati e detenuti in condizioni disumane. La guerra coloniale per soggiogare la Libia durò oltre vent’anni, e costò l’annientamento di un ottavo della popolazione, scrive Del Boca.
Infatti, quando nella seconda parte del 1930 il fascismo con i generali Badoglio e Graziani, e il beneplacito di De Bono, ministro delle colonie, e dello stesso Mussolini decisero di imporre definitivamente la pace italiana all’inquieta colonia, riuscirono a domare la rivolta della Cirenaica solo a prezzo della deportazione in campi di concentramento in pieno deserto di almeno 100.000 persone, 40.000 delle quali morirono nel corso dell’operazione. Come è noto la rivolta ebbe termine solo quando l’anziano, abile e coraggioso leader Omar el Muktar fu isolato, catturato e vilmente impiccato (e quando Gheddafi sarà accolto con tutti gli onori da Berlusconi nel giugno 2009, si presenterà con appuntata orgogliosamente sul petto la fotografia di quell’episodio).
Se può consolare, non ricevettero un trattamento migliore dei libici deportati dopo Sciara Sciat i soldati del regio esercito caduti prigionieri degli austriaci nel corso della Grande Guerra. L’Italia si distinse infatti tra le nazioni belligeranti per il fatto di sospettare i propri militari che si erano arresi al nemico di codardia e tradimento, e di lesinare quindi loro cibo e altri generi di conforto che per le convenzioni internazionali spettava alla madrepatria fornire.
Una ferocia, questa, che contraddistinse in particolare Cadorna ma non lui solo, e avrebbe dato i suoi frutti avvelenati a guerra finita all’interno del Paese con il fascismo, nota giustamente Del Boca, in quella che si sarebbe trasformata – aggiungo io – nella “Guerra dentro” (ma non solo dentro come si è visto per la Libia, e vedremo per l’Etiopia) che è la sua essenza.
Il fascismo non inventò certo dal nulla la violenza coloniale italiana, ma la inasprì – scrive Del Boca – aggiungendo alla violenza razzista che l’Italia aveva in comune con le altre potenze coloniali la propensione assoluta alla violenza e la totale mancanza di scrupoli rispetto al suo esercizio che caratterizzavano l’uomo nuovo, l’italiano nuovo, che il fascismo aveva portato al potere. Del resto, occorre tenere presente che sono stati gli italiani a inventare il fascismo e a farne l’ideologia della violenza e della sopraffazione sull’altro esaltate in se stesse, e non il fascismo ad avere reso cattivi gli italiani.
Del Boca ricorda intere popolazioni somale ridotte durante il ventennio in sostanziale schiavitù dei padroni italiani, come in un gigantesco campo di lavoro dove la cultura squadrista della violenza gratuita si aggiungeva a quella razzista propria della situazione coloniale, potenziandola.
Uno dei meriti storici più rilevanti di Del Boca fu senz’altro però quello di aver documentato in modo inoppugnabile – tanto da costringere a scusarsi chi per anni si era ostinato a negarlo, come Indro Montanelli – non solo l’utilizzo dei gas venefici vietati dalle convenzioni internazionali nate dai disastri della Grande Guerra, da parte dell’Italia nel corso della sua aggressione ingiustificata all’Etiopia, ma anche il fatto che quell’utilizzo nasceva da precisi ordini impartiti per iscritto da Mussolini ai generali Badoglio e Graziani.
Dopo la battaglia dell’Amba Aradam la caccia all’etiope in fuga è descritta dal gerarca Pavolini in termini da caccia grossa che paiono l’emblema della deumanizzazione per animalizzazione del nemico, in una situazione nella quale non basta la superiorità data dal fatto di disporre di aerei e mitragliatori moderni, ma occorre il massiccio ricorso all’iprite per sterminare oltre che vincere. La descrizione da parte delle vittime dei bombardamenti subiti che Del Boca riporta, è terrificante.
Ma la ferocia fascista in Etiopia documentata da Del Boca non si ferma all’uso dei gas proibiti. Si scatena contro installazioni mediche; stermina i nemici fatti prigionieri a partire dai generali non considerandoli militari in guerra com’erano, ma ribelli; applica rappresaglie degne dell’occupazione tedesca dell’Italia di lì a poco; dà mano libera alle sue truppe libiche di religione islamica di vendicarsi sugli etiopi in gran parte cristiani delle atrocità da questi ultimi commesse, anch’essi al seguito e nell’interesse degli italiani, in Libia.
Fu dopo il fallito attentato a Graziani del 19 febbraio 1937 che la ferocia fascista contro i civili si trasformò in autentica caccia al nero che portò secondo alcune stime alla strage di 1400-6000, ma secondo altre che considerano un periodo più ampio di 30.000, civili innocenti. E determinò tra altri fenomeni la deportazione dei notabili della capitale, e la curiosa e feroce vicenda della strage di indovini e cantastorie considerati tra i responsabili della rivolta. Il 3 agosto Graziani poteva scrivere a Mussolini di quasi 2.000 esecuzioni sommarie effettuate dal terzo giorno dopo l’attentato in poi.
Le stragi proseguivano infatti, sempre incoraggiate per iscritto da Roma, e culminavano nei giorni tra 19 e 21 maggio 1937 con l’assalto alla città conventuale copta di Debrà Libanòs, alcuni dei cui appartenenti erano vagamente sospettati di responsabilità nell’attentato, e la fucilazione di un numero di monaci e altri civili compreso tra 1.400 e 2.033, che si aggiungono alle vittime di altre stragi compiute negli stessi giorni.
Stragi, tutte, che non possono non richiamare alla mente se lette oggi altre delle quali sarebbero stati di lì a poco vittime gli stessi italiani, a partire da quella delle Fosse Ardeatine, il che sembra confermare nei fatti quanto scrisse Aimé Césaire, che la stagione nazifascista corrispose al trasferimento in Europa di ciò che da tempo gli europei facevano alle altre popolazioni della terra.
Ma già, è noto che la vita e la morte degli africani e dei non caucasici in genere contavano – e contano tutt’oggi (vai al link) – meno, e così di queste stragi perpetuate dagli italiani in Africa si era persa quasi totalmente memoria anche quando venivano elencate le tante altre atrocità commesse dal fascismo in patria.
Non si sarebbero comportati del resto meglio gli italiani, prosegue il volume, di lì a poco durante l’occupazione della Slovenia. Tra altri misfatti e crudeltà Del Boca ricorda così le esecuzioni sommarie dei partigiani e dei civili sospettati di connivenza, i rastrellamenti, i trasferimenti coatti della popolazione civile nei campi di concentramento. In quello dell’isola di Arbe (Rab), il tasso di mortalità era del 19%, maggiore che in quello tedesco di Buchenwald.
Sono più noti i crimini fascisti in Italia durante la stagione squadrista, il regime, la RSI, tra i quali Del Boca individua uno stile e un ideologia comune, una sostanziale continuità che è nell’essenza della weltanshauung fascista.
Da ultimo, Del Boca affronta anche due capitoli scomodi, quello delle foibe sul confine italo-sloveno e delle vendette consumate isolatamente dagli antifascisti dopo la Liberazione, capitoli che non devono essere certo neppure essi rimossi, ma neppure considerati in modo avulso dagli atti di ferocia della fase che li ha preceduti che se certo non li giustificano, però li rendono storicamente inquadrabili e li restituiscono alla loro reale dimensione.
Un’attenzione, infine, nel libro è dedicata alla denuncia delle coperture delle quali godettero dopo il 25 aprile da parte italiana i criminali di guerra che si erano macchiati di crimini orrendi in Libia, Somalia, Etiopia, Slovenia durante il ventennio. Una protezione e una rimozione che ha contributito a far sì che il mito degli “Italiani, brava gente”, dalla cui ipocrisia Del Boca appare ancora più infastidito che dagli stessi crimini la cui scoperta gli ha consentito di confutarlo, abbia prosperato finora e continui incredibilmente a prosperare nella retorica nazionalista, che sta trovando negli ultimi anni nuova fortuna. E che ha consentito ancora il riproporsi del non essere gli italiani per niente brava gente in occasioni recenti, come quella dei giorni genovesi del G8 (vai al link).
Anche di fronte agli avvenimenti degli ultimi anni, peraltro, Del Boca non cessò di guardare con amore verso la verità e rabbia verso l’ipocrisia, alla sua Africa. E nel 2011, quando le potenze neocoloniali decisero di ritornare, a un secolo esatto di distanza dall’invasione italiana, ad aggredire la Libia, fu richiesto di pareri da esperto di cose africane, e libiche soprattutto. Ricordo che Del Boca fu in quel momento – nel quale i più digrignavano i denti contro il bizzarro e arrogante beduino che, barcamenandosi tra ovest ed est, era riuscito a tenere in scacco per anni gli appetiti neocoloniali sul petrolio e sui dollari della sua terra – tra i pochi ad ammonire che Gheddafi poteva forse non essere la soluzione perfetta, ma per governare la complessa frammentazione tribale della Libia era comunque l’unica. Non fu ascoltato; e dall’assassinio del colonnello e la fine del suo sogno panafricano la Libia, caduta in balia degli appetiti più feroci di dentro e di fuori, rimane ancora dieci anni dopo un bagno di sangue senza soluzione. Un luogo di schiavitù, di miseria e di morte come chi non si gira, di nuovo, dall’altra parte per non vedere, ben sa.
Parte I: Un libro-inchiesta sull’Ospedale Psichiatrico in Italia a metà anni ‘60
Nel 1966 Del Boca aveva pubblicato per la collana “I radar” delle Edizioni Dell’Albero di Torino il volume Manicomi come lager. Centomila ostaggi da liberare. Una legge iniqua, e mi pare che possiamo iniziare dal contributo importante che ha dato al miglioramento della psichiatria italiana, un contributo del resto che gli è ampiamente riconosciuto dalla storica Valeria Paola Babini nel tracciare la storia della nostra psichiatria nel corso del Novecento (Liberi tutti, Il mulino, 2009).
Sulla copertina una frase di Georges Daumézon, uno dei maestri della psicoterapia istituzionale in Francia tra gli anni ’40 e ’60, che oggi, di fronte alle discussioni cui ha dato luogo la II Conferenza nazionale sulla relazione tra “psichiatria” e “salute mentale di comunità”, non può non sembrare illuminante: «Il medico può combattere la malattia, solo la società può combattere l’alienazione».
Questa è del resto la posizione di Del Boca, che rivolge il suo libro-inchiesta per informare sulle cose della psichiatria e degli Ospedali Psichiatrici (OP) l’opinione pubblica, e la politica che in quel momento si trovava di fronte alla necesità di scelte importanti al riguardo.
L’intento è fin dalla breve premessa quello della denuncia della condizione degli OP italiani in quel momento, ed è già interessante scorrere la serie dei ringraziamenti. Manca Basaglia, perché evidentemente due anni prima de L’istituzione negata il suo lavoro a Gorizia non era ancora così noto, anche se poi è ricordato nel testo a p. 34 («Un esperimento ancora più di rilievo è quello in atto all’O.P. di Gorizia, sotto la direzione del prof. F. Basaglia. A Gorizia non ci si è accontentati di costituire un reparto “aperto”, ma si è voluto etendere questo regime a tutto l’ospedale (…) così da realizzare sulle sue ceneri una “Comunità Terapeutica”»).
 Sono invece presenti Edoardo Balduzzi, propugnatore per l’Italia della “psichiatria di settore” e Mario Tobino cui Del Boca si riferisce come a un amico personale e apprezza l’impronta umanitaria dei romanzi, che anni dopo avrebbe assunto una posizione nostalgica e conservatrice rispetto all’OP. C’è anche Giorgio Coda, lo psichiatra di Torino che anni dopo sarebbe stato al centro di una vicenda giudiziaria per comportamenti sadici verso pazienti adulti e bambini.
Sono invece presenti Edoardo Balduzzi, propugnatore per l’Italia della “psichiatria di settore” e Mario Tobino cui Del Boca si riferisce come a un amico personale e apprezza l’impronta umanitaria dei romanzi, che anni dopo avrebbe assunto una posizione nostalgica e conservatrice rispetto all’OP. C’è anche Giorgio Coda, lo psichiatra di Torino che anni dopo sarebbe stato al centro di una vicenda giudiziaria per comportamenti sadici verso pazienti adulti e bambini.Quanto al libro, si apre con la nota frase, pronunciata il 20 settembre 1965, con la quale il ministro della sanità Luigi Mariotti paragonò gli ospedali psichiatrici a “veri e propri lager germanici” e a “bolge dantesche”. A queste affermazioni – ed è bene rileggerlo perché c’è sempre il rischio che alla ricostruzione storica poi tutti possano sembrare dalla parte “giusta” fin da subito – reagirono offese l’AMOPI, forte di 800 iscritti, con il suo presidente Ferdinando Barison e la SIP con il suo presidente Mario Gozzano, che considerarono sostanzialmente infondate e frutto di generalizzazione e superficialità le critiche alla situazione da parte di Mariotti. L’inchiesta condotta dal ministero già nel 1962 e il Libro bianco pubblicato nel 1965 avevano messo in luce carenze drammatiche nel numero dei posti letto, dell’ampiezza degli edifici, nel personale. Due psichiatri di quegli anni, il prof. Aschieri di Varese e Max Beluffi di Mombello danno della condizione degli ospedali psichiatrici una rappresentazione drammatica. I successivi capitoli documentano le condizioni di questi luoghi, che ricordano “più il carcere che l’ospedale”, le modalità d’ingresso con il sequestro di ogni oggetto personale e la vestizione di un’uniforme spesso sgualcita e fuori taglia. Nelle parole di un internato e in quelle dello psichiatra Giorgio Ceccarelli di Genova questi riti di iniziazione aprono il processo di umiliazione e inferiorizzazione, che fu reso celebre in quegli anni dai libri di Goffmann e di Basaglia. La visita dell’ospedale di via Giulio a Torino, dove colpisce il sovraffollamento e «lo spettacolo di desolazione e di inedia è deprimente, ma è nulla al confronto di quello che il manicomio offre d’inverno, quando tutte le malate sono costrette in camerata». Le camerate sono immense, fetide a volte, l’atmosfera di carcere e lazzaretto ricorda gli ambienti descritti da Dickens. Né vale il comodo alibi per il quale dopo i primi tempi di internamento gli psicotici diventerebbero insensibili alle modalità con le quali sono trattati. A Collegno gli spazi sono più ampi, è più presente l’ergoterapia ma questo non basta a migliorare molto le cose. A Lucca, in compagnia di Tobino, Del Boca incontra una situazione un po’ migliore, ma solo per quanto gli consente il contesto a partire dalle dimensioni delle camerate. Né va meglio in due ospedali più recenti – il Santa Maria della Pietà di Roma e il Savonera presso Torino. Le stesse dimensioni spersonalizzanti, la stessa sciatteria. Il reparto delle sudice di Savonera ospita ottanta donne in tre camerate, tra i 19 e i 94 anni «ma non c’è più età su questi volti che il sole non sfiora da mesi o da anni; non cè più pudore questi sguardi abituati alla più avvilente promiscuità; non c’è più speranza in questi occhi che hanno come unico spettacolo il rapido muoversi delle labbra delle confabulatrici, l’agitarsi delle contenute, il volto scarno e devastato delle più vecchie, ridotte a larve […]. Sono in gran parte legate con le cinghie di contenzione». Bolge dantesche, insomma!
Certo, alcune rare situazioni appaiono a Del Boca migliori, perché qualche passo avanti è stato fatto in direzione della personalizzazione della cura. È il caso di Varese, costruito da Fiamberti e diretto in quel momento da Edoardo Balduzzi. O quello del Chiarugi (San Salvi) di Firenze, o situazioni più limitate, come “Villa Verde” e “Villa Azzurra”, destinato ai ragazzi (che sarebbe poi stata al centro, però, del processo Coda), a Torino, “Villa Donato” a Bologna, o la Gorizia di Basaglia.
Un capitolo è dedicato al personale, scarso e malpagato e, per quanto riguarda gli infermieri – che si sentono «manovali della pazzia» – per nulla formato, ma complessivamente fortemente bisognoso di riqualificazione. Pressocché ignorati sono il lavoro d’équipe, la riflessione psicoanalitica sulle relazioni di cura, applicata senza reali obiettivi di cura l’ergoterapia. Questa la situazione nella maggior parte degli ospedali psichiatrici. Ancora peggiore fuori, dove i Centri di Igiene Mentale sono pochissimi, ancora meno gli ospedali diurni, scarso l’interesse per la psichiatria di settore.
Quanto agli orientamenti degli psichiatri, il professor Benvenuti li aveva sintetizzati in quel periodo così: «ci sono gli ospedalisti e gli antiospedalisti; ci sono i settorialisti e gli antisettorialisti; ci sono quelli che prevedono e auspicano reparti psichiatrici negli ospedali civili e quelli che non vogliono questo».
Dopo una lunga digressione sulla situazione in Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti (sono gli stessi riferimenti che utilizza Basaglia in quegli anni, ed erano evidentemente i più interessanti), il libro-inchiesta si concentra sulla “riforma Mariotti” per come si presentava in quella fase della discussione, che durava già da dieci anni: sostituzione dell’iscrizione al Casellario Giudiziario dei ricoverati definitivi in manicomio introdotta con il Codice di Procedura Penale dal regime fascista a peggiorare la legge del 1904, con l’istituzione di una “Anagrafe psichiatrica” limitata ai casi ritenuti pericolosi; tetto massimo di posti letto negli ospedali a 500 e massiccio incremento degli organici; forte incremento dei servizi extraospedalieri; previsioni per il reinserimento lavorativo dei dimessi dall’OP. Del Boca riporta le critiche dell’AMOPI, che consistevano nel rifiuto schedatura dei malati anche nella forma edulcorata che era proposta; nella contrarietà alla separazione tra OP e servizi extraospedalieri prevista dal legislatore, opposta al modello del settore sposato in quegli anni anche dall’OMS (e già allora contestato da alcuni per il rischio di una «psichiatrizzazione dell’intera società»); nella richiesta che non si ignorasse la questione delle Opere Pie, forti in quel momento di 35.000 posti letto; nel fatto di cogliere nella proposta di trasferire gli internati tranquilli in istituti a carattere più assistenziale rispetto all’OP, l’abbandono di fatto di ogni prospettiva di reinserimento per quello che li riguardava. E su quest’ultimo punto mi hanno colpito le parole del prof. Garavaglia, per l’assonanza con quelle che ho sempre sentito da parte di Antonio Slavich, in quel caso a proposito dei degenti che erano rimasti negli ex-OP dopo la legge 180: «Questi vecchi malati (…) in parte sono la testimonianza della nostra inefficienza. (…). Della stratificazione di incompetenze, di negligenze, di pigrizie, di sonnolenze. Devono rrimanere nel nostro ospedale a ricordarci che noi non dobbiamo più essere così. Altro che eliminarli! Se noi li eliminiamo allontanandoli, facciamo come colui che elimina il senso di colpa e continua a fare il delinquente». Del Boca riporta poi anche i contenuti del progetto di 23 deputati di PCI e PSIUP a prima firma Marcella Balconi, che appare più avanzato rispetto a quello ministeriale: nessuna schedatura psichiatrica, tetto di posti letto per gli OP a 500, organizzazione a settore polarizzata sui servizi esterni diurni e notturni, con l’istituzione tra l’altro di un servizio per adulti e uno per minori per ogni area di 70-100.000 abitanti, forti tra tutti di non meno di 5.000 medici.
Nessuno insomma, mi pare evidente, pensava in quel momento alla possibilità di lasciarsi del tutto l’OP alle spalle, cui Basaglia aveva già fatto riferimento due anni prima a Londra; non c’è da stupirsi né da perdersi in minuzie perciò, credo, se la legge che dodici anni dopo ha chiuso gli OP viene ovviamente chiamata da tutti: “Legge Basaglia”!
Nell’intervista che rilascia a Del Boca e chiude il volume, il ministro insiste sullo stretto collegamento tra riforma degli OP e riforma ospedaliera; rivendica il carattere e la gestione solo sanitari della prevista “Anagrafe psichiatrica”, e manifesta comunque disponibilità a ridicutere questo come altri aspetti; rivendica il carattere rivoluzionario della riorganizzazione degli OP (dei quali è però previsto un potenziamento) e l’introduzione, tra l’altro, nel loro organico dello psicologo, e poi quello dell’istituzione dei CIM, dei centri diurni e notturni, del lavoro protetto.
Nel suo commento, l’autore auspica che effettivamente alcuni ritocchi possano essere effettuati al progetto Mariotti, ma paventa anche il rischio di un anacquamento, o di nuovi rinvii. Infine, auspica l’inizio di quella che oggi definiremmo un’ampia campagna di lotta allo stigma a partire dalle scuole e dal moltiplicarsi di iniziative come quella della nascita a Firenze dell’Associazione per la lotta contro le malattie mentali, che tanta parte avrebbe avuto nel dibattito degli anni successivi, e come quella delle iniziative che si vanno moltiplicandosi in quel momento per ripristinare il contatto tra società e internati attraverso, in particolare, l’organizzazione di iniziative a carattere culturale e artistico. E conclude: «Ciò che dobbiamo raggiungere è il convincimento che non esistono due diverse società, quella della gente “normale” e l’altra, ingiustamente segregata, dei malati di mente; e che la rivoluzione in atto in psichiatria non sarà mai completa se, come ha scritto Tobino, non interverrà l’aiuto “da uomo a uomo”, quell’atto che è indispensabile perché tanti infelici possano passare “dalle nebbie alla luce”».
Completano il testo tre appendici: la relazione di presentazionme e il contenuto del disegno di legge Mariotti; l’intervento di Edoardo Balduzzi al congresso di Varese del marzo 1965 in favore del modello della psichiatria di settore; un articolo scritto da Mario Tobino rispetto alla costruzione del nuovo OP di Vicenza, in favore dell’umanizzazione degli OP.
Parte II: Perché gli italiani non sono brava gente
Del Boca però non è noto al grande pubblico per il suo contributo critico alla psichiatria. Per un altro illustre storico del colonialismo italiano, infatti: «oggi si ricordano solo i gas di Mussolini, Italiani brava gente, le polemiche… ma si dimentica che tutto ciò era basato su sei straordinari volumi di ricerca editi tra gli anni Settanta e Ottanta che hanno, cambiato la conoscenza del colonialismo italiano».
Nicola Labanca allude qui evidentemente a volumi come Gli italiani in Africa orientale (Laterza, 1982), Ras Immiru, aristocratico e guerriero (Loescher, 1985), Gli italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi (Mondadori, 1994), Gheddafi: una sfida dal deserto (Laterza, 1998), A un passo dalla forca: atrocità e infamie dell’occupazione italiana della Libia nelle memorie del patriota Mohamed Fekini (Mondolibri, 2007), Il Negus. Vita e morte dell’ultimo Re dei Re (Laterza, 2007), La guerra d’Etiopia: l’ultima impresa del colonialismo (RCS, 2020).
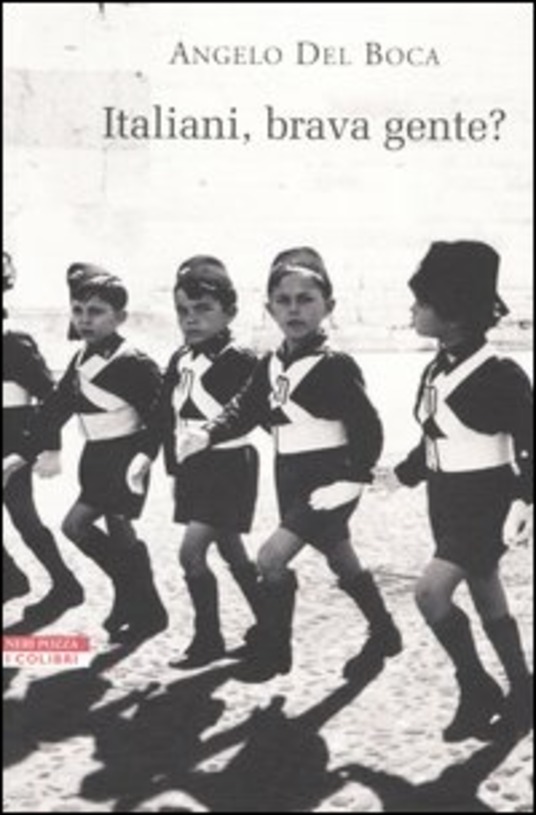 Tra questi volumi vorrei proporre qui la rilettura di quello più noto al pubblico non specialistico, che rappresenta anche una sorta di sintesi degli altri e che con un titolo particolarmente efficace è diventato il simbolo di un modo diverso, opposto – meno retorico e più onesto cioè – di considerare la storia italiana contemporanea: Italiani, brava gente? Un mito duro a morire (Neri Pozza, 2004).
Tra questi volumi vorrei proporre qui la rilettura di quello più noto al pubblico non specialistico, che rappresenta anche una sorta di sintesi degli altri e che con un titolo particolarmente efficace è diventato il simbolo di un modo diverso, opposto – meno retorico e più onesto cioè – di considerare la storia italiana contemporanea: Italiani, brava gente? Un mito duro a morire (Neri Pozza, 2004).I primi con i quali gli italiani se la presero a Italia da poco unita furono, nella ricostruzione di Del Boca, gli italiani stessi. Chi ha dipinto il Risorgimento come anelito unitario unanime da tutta la penisola ha forse tralasciato di ricordare tra tanti altri momenti le stragi di Pontelandolfo e Casalbuti, due paesi del Sannio che il 15 agosto 1861 subirono dall’esercito sabaudo lo stesso trattamento che neppure un secolo dopo Boves subì da parte dell’occupante tedesco. Il che seguiva, del resto, altre pagine vergognose, come la macchia più vistosa dell’epopea garibaldina costituita dall’eccidio ordinato da Nino Bixio a Bronte, nell’agosto 1860.
La prima impresa dell’Italia all’estero sulla quale Del Boca si sofferma è invece la partecipazione, con le altre potenze coloniali, alla repressione della rivolta dei boxer in Cina; tutt’altro che un’impresa civilizzatrice come sosteneva la propaganda, ma una violenta aggressione imperialista nelle parole degli stessi ufficiali italiani.
Siamo al 1911 quando l‘Italia decide di occupare, senza nessuna plausibile giustificazione se non avere la propria parte della rapina coloniale, la Libia. A una strage di soldati italiani compiuta dai turchi affiancati dai ribelli arabi di Tripoli e dell’oasi di Sciara Sciat, gli occupanti italiani reagivano massacrando in una rappresaglia tra 1000 e 4000 arabi, in gran parte civili del tutto estranei ai fatti. Altrettanti, che variano a seconda delle stime, erano deportati nelle piccole isole del sud Italia e ivi rimasero a lungo esiliati e detenuti in condizioni disumane. La guerra coloniale per soggiogare la Libia durò oltre vent’anni, e costò l’annientamento di un ottavo della popolazione, scrive Del Boca.
Infatti, quando nella seconda parte del 1930 il fascismo con i generali Badoglio e Graziani, e il beneplacito di De Bono, ministro delle colonie, e dello stesso Mussolini decisero di imporre definitivamente la pace italiana all’inquieta colonia, riuscirono a domare la rivolta della Cirenaica solo a prezzo della deportazione in campi di concentramento in pieno deserto di almeno 100.000 persone, 40.000 delle quali morirono nel corso dell’operazione. Come è noto la rivolta ebbe termine solo quando l’anziano, abile e coraggioso leader Omar el Muktar fu isolato, catturato e vilmente impiccato (e quando Gheddafi sarà accolto con tutti gli onori da Berlusconi nel giugno 2009, si presenterà con appuntata orgogliosamente sul petto la fotografia di quell’episodio).
Se può consolare, non ricevettero un trattamento migliore dei libici deportati dopo Sciara Sciat i soldati del regio esercito caduti prigionieri degli austriaci nel corso della Grande Guerra. L’Italia si distinse infatti tra le nazioni belligeranti per il fatto di sospettare i propri militari che si erano arresi al nemico di codardia e tradimento, e di lesinare quindi loro cibo e altri generi di conforto che per le convenzioni internazionali spettava alla madrepatria fornire.
Una ferocia, questa, che contraddistinse in particolare Cadorna ma non lui solo, e avrebbe dato i suoi frutti avvelenati a guerra finita all’interno del Paese con il fascismo, nota giustamente Del Boca, in quella che si sarebbe trasformata – aggiungo io – nella “Guerra dentro” (ma non solo dentro come si è visto per la Libia, e vedremo per l’Etiopia) che è la sua essenza.
Il fascismo non inventò certo dal nulla la violenza coloniale italiana, ma la inasprì – scrive Del Boca – aggiungendo alla violenza razzista che l’Italia aveva in comune con le altre potenze coloniali la propensione assoluta alla violenza e la totale mancanza di scrupoli rispetto al suo esercizio che caratterizzavano l’uomo nuovo, l’italiano nuovo, che il fascismo aveva portato al potere. Del resto, occorre tenere presente che sono stati gli italiani a inventare il fascismo e a farne l’ideologia della violenza e della sopraffazione sull’altro esaltate in se stesse, e non il fascismo ad avere reso cattivi gli italiani.
Del Boca ricorda intere popolazioni somale ridotte durante il ventennio in sostanziale schiavitù dei padroni italiani, come in un gigantesco campo di lavoro dove la cultura squadrista della violenza gratuita si aggiungeva a quella razzista propria della situazione coloniale, potenziandola.
Uno dei meriti storici più rilevanti di Del Boca fu senz’altro però quello di aver documentato in modo inoppugnabile – tanto da costringere a scusarsi chi per anni si era ostinato a negarlo, come Indro Montanelli – non solo l’utilizzo dei gas venefici vietati dalle convenzioni internazionali nate dai disastri della Grande Guerra, da parte dell’Italia nel corso della sua aggressione ingiustificata all’Etiopia, ma anche il fatto che quell’utilizzo nasceva da precisi ordini impartiti per iscritto da Mussolini ai generali Badoglio e Graziani.
Dopo la battaglia dell’Amba Aradam la caccia all’etiope in fuga è descritta dal gerarca Pavolini in termini da caccia grossa che paiono l’emblema della deumanizzazione per animalizzazione del nemico, in una situazione nella quale non basta la superiorità data dal fatto di disporre di aerei e mitragliatori moderni, ma occorre il massiccio ricorso all’iprite per sterminare oltre che vincere. La descrizione da parte delle vittime dei bombardamenti subiti che Del Boca riporta, è terrificante.
Ma la ferocia fascista in Etiopia documentata da Del Boca non si ferma all’uso dei gas proibiti. Si scatena contro installazioni mediche; stermina i nemici fatti prigionieri a partire dai generali non considerandoli militari in guerra com’erano, ma ribelli; applica rappresaglie degne dell’occupazione tedesca dell’Italia di lì a poco; dà mano libera alle sue truppe libiche di religione islamica di vendicarsi sugli etiopi in gran parte cristiani delle atrocità da questi ultimi commesse, anch’essi al seguito e nell’interesse degli italiani, in Libia.
Fu dopo il fallito attentato a Graziani del 19 febbraio 1937 che la ferocia fascista contro i civili si trasformò in autentica caccia al nero che portò secondo alcune stime alla strage di 1400-6000, ma secondo altre che considerano un periodo più ampio di 30.000, civili innocenti. E determinò tra altri fenomeni la deportazione dei notabili della capitale, e la curiosa e feroce vicenda della strage di indovini e cantastorie considerati tra i responsabili della rivolta. Il 3 agosto Graziani poteva scrivere a Mussolini di quasi 2.000 esecuzioni sommarie effettuate dal terzo giorno dopo l’attentato in poi.
Le stragi proseguivano infatti, sempre incoraggiate per iscritto da Roma, e culminavano nei giorni tra 19 e 21 maggio 1937 con l’assalto alla città conventuale copta di Debrà Libanòs, alcuni dei cui appartenenti erano vagamente sospettati di responsabilità nell’attentato, e la fucilazione di un numero di monaci e altri civili compreso tra 1.400 e 2.033, che si aggiungono alle vittime di altre stragi compiute negli stessi giorni.
Stragi, tutte, che non possono non richiamare alla mente se lette oggi altre delle quali sarebbero stati di lì a poco vittime gli stessi italiani, a partire da quella delle Fosse Ardeatine, il che sembra confermare nei fatti quanto scrisse Aimé Césaire, che la stagione nazifascista corrispose al trasferimento in Europa di ciò che da tempo gli europei facevano alle altre popolazioni della terra.
Ma già, è noto che la vita e la morte degli africani e dei non caucasici in genere contavano – e contano tutt’oggi (vai al link) – meno, e così di queste stragi perpetuate dagli italiani in Africa si era persa quasi totalmente memoria anche quando venivano elencate le tante altre atrocità commesse dal fascismo in patria.
Non si sarebbero comportati del resto meglio gli italiani, prosegue il volume, di lì a poco durante l’occupazione della Slovenia. Tra altri misfatti e crudeltà Del Boca ricorda così le esecuzioni sommarie dei partigiani e dei civili sospettati di connivenza, i rastrellamenti, i trasferimenti coatti della popolazione civile nei campi di concentramento. In quello dell’isola di Arbe (Rab), il tasso di mortalità era del 19%, maggiore che in quello tedesco di Buchenwald.
Sono più noti i crimini fascisti in Italia durante la stagione squadrista, il regime, la RSI, tra i quali Del Boca individua uno stile e un ideologia comune, una sostanziale continuità che è nell’essenza della weltanshauung fascista.
Da ultimo, Del Boca affronta anche due capitoli scomodi, quello delle foibe sul confine italo-sloveno e delle vendette consumate isolatamente dagli antifascisti dopo la Liberazione, capitoli che non devono essere certo neppure essi rimossi, ma neppure considerati in modo avulso dagli atti di ferocia della fase che li ha preceduti che se certo non li giustificano, però li rendono storicamente inquadrabili e li restituiscono alla loro reale dimensione.
Un’attenzione, infine, nel libro è dedicata alla denuncia delle coperture delle quali godettero dopo il 25 aprile da parte italiana i criminali di guerra che si erano macchiati di crimini orrendi in Libia, Somalia, Etiopia, Slovenia durante il ventennio. Una protezione e una rimozione che ha contributito a far sì che il mito degli “Italiani, brava gente”, dalla cui ipocrisia Del Boca appare ancora più infastidito che dagli stessi crimini la cui scoperta gli ha consentito di confutarlo, abbia prosperato finora e continui incredibilmente a prosperare nella retorica nazionalista, che sta trovando negli ultimi anni nuova fortuna. E che ha consentito ancora il riproporsi del non essere gli italiani per niente brava gente in occasioni recenti, come quella dei giorni genovesi del G8 (vai al link).
Anche di fronte agli avvenimenti degli ultimi anni, peraltro, Del Boca non cessò di guardare con amore verso la verità e rabbia verso l’ipocrisia, alla sua Africa. E nel 2011, quando le potenze neocoloniali decisero di ritornare, a un secolo esatto di distanza dall’invasione italiana, ad aggredire la Libia, fu richiesto di pareri da esperto di cose africane, e libiche soprattutto. Ricordo che Del Boca fu in quel momento – nel quale i più digrignavano i denti contro il bizzarro e arrogante beduino che, barcamenandosi tra ovest ed est, era riuscito a tenere in scacco per anni gli appetiti neocoloniali sul petrolio e sui dollari della sua terra – tra i pochi ad ammonire che Gheddafi poteva forse non essere la soluzione perfetta, ma per governare la complessa frammentazione tribale della Libia era comunque l’unica. Non fu ascoltato; e dall’assassinio del colonnello e la fine del suo sogno panafricano la Libia, caduta in balia degli appetiti più feroci di dentro e di fuori, rimane ancora dieci anni dopo un bagno di sangue senza soluzione. Un luogo di schiavitù, di miseria e di morte come chi non si gira, di nuovo, dall’altra parte per non vedere, ben sa.
![]()








0 commenti