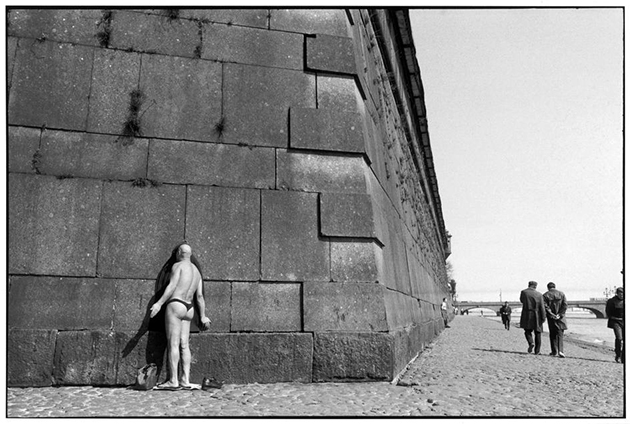
La notizia l'apprendo casualmente mentre sto cercando su internet qualche articolo per un corso di formazione sul suicidio. Prima ancora di leggere il titolo, mi colpisce la foto in primo piano sulla pagina del sito. Ma sì, è proprio l’entrata degli Spedali Civili di Brescia. Quella brutta facciata di architettura fascista che ho dovuto vedermi davanti per i cinque anni di specializzazione, e che di sicuro non aiuta l’umore. L’articolo [1], del 30 marzo, parla però di qualcosa di ben peggiore. In breve, attenendomi a quanto viene riportato visto che all’epoca dei fatti ero ancora indaffarato con le formule di biochimica, nel 2005 una donna quarantenne ricoverata nel reparto di psichiatria tenta il suicidio. “Avrebbe approfittato del momento di caos dovuto ad un'altra emergenza:il personale sanitario era impegnato a bloccare un altro paziente che cercava di fuggire dal reparto“.
Fin qui, purtroppo non una notizia sorprendente per chi lavora in questi servizi. Al limite ci sarebbe spazio per ravvivare l’infinita discussione tra chi vorrebbe gli SPDC blindati, e chi invece chiusi, semi aperti, o spalancati. Nel frattempo comunque, nell’attesa biblica di una soluzione alla disomogeneità delle strutture, i giudici si sono portati avanti e infatti, più concretamente, quelli del Tribunale di Brescia condannano l’azienda sanitaria a risarcire la paziente con 700 mila euro e a un vitalizio di oltre 18 mila euro all’anno. Motivo: “la donna avrebbe dovuto comunque essere controllata da medici e infermieri“. Ora, detta così, breve e semplice la notizia, non sappiamo se la paziente ha poi riportato danni irreversibili, non è più autosufficiente e allora magari ben venga per lei il sussidio. Resta però il giudizio, la condanna dell’omissione di vigilanza, il richiamo alla posizione di garanzia (maledetta!). E quel ritorno del reale, sempre in agguato nel riprendere noi operatori dai tentativi di fuga in avanti verso il diritto di cura, per riportarci a quello che in fondo forse si vuole e si pretende, il dovere di custodia. Mentre riflettevo su questa cosa, e un po' mi spaventavo, come quando vado a sentire per masochismo i convegni di avvocati e medici legali, e torno a casa col pensiero di licenziarmi, mi accorgo delle potenzialità dei motori di ricerca che tracciano le ricerche. A quella di Brescia è collegata la notizia, anch’essa recente, di un’altra vicenda riguardante sempre la psichiatria lombarda [2]. Sono fatti accaduti tre anni fa nel SPDC di Treviglio, bassa bergamasca, con due psichiatri indagati per omicidio colposo. Una paziente di quarant’anni, anche lei, dopo essere stata ricoverata per un tentativo di suicidio, viene trasferita in una clinica fuori regione. Dove, purtroppo, riesce a togliersi la vita. Secondo il consulente della Procura, “le dimissioni dall'ospedale furono affrettate e le poche ore di ricovero […] non sarebbero state sufficienti a investigare correttamente il nuovo stato della paziente”.
Senza voler entrare nel merito di queste vicende, anche per l’esiguità delle informazioni che trasformerebbero in chiacchiera ogni discorso, sarebbe opportuno riflettere sul sincronismo che si sta verificando in questo Paese e sul rumore di fondo dell’attualità.
Alle due vicende si associa infatti quella che riguarda il Governo italiano e la decisione di costituire l’avvocatura dello Stato davanti alla Corte Costituzionale per il processo a carico di Marco Cappato. Indagato, e assolto, per l’aiuto fornito a Fabiano Antoniani, dj Fabo, nello scegliere di morire in una clinica svizzera. Si tratta di un procedimento sollevato dalla Corte d'Assise di Milano che, dopo aver assolto Cappato in quanto la sua condotta non aveva inciso sulla decisione di dj Fabo, aveva sollevato dubbi di incostituzionalità per l’equiparazione tra aiuto e istigazione al suicidio (articolo 580 del codice penale) e la conseguente sproporzione della condanna per l’aiuto al suicidio (dai 6 ai 12 anni, come per l’istigazione). L'articolo 580 del codice penale è una legge del 1930, risalente al codice penale promulgato dal regime fascista (ancora loro…), ci ricordano alcuni giuristi e intellettuali firmatari dell’appello dell’Associazione Luca Coscioni [3].
Appello che chiedeva al Governo, inutilmente, di non entrare sul tema. Su cui invece, pronte come al solito, sono piovute le opinioni dei difensori della vita e della famiglia, e i moniti a non considerare la morte un diritto. Parole, se posso, che pure nella loro ripetitività conservano il potere raggelante di stupire in negativo per quanto riescono a essere distanti dal dolore privato e dall'insopportabile sofferenza di chi si trova nella possibilità finale della propria esistenza. E mentre tenta di riacquistare, anche da immobilizzato nel proprio corpo, il diritto a un’ultima azione, deve ancora difendersi dai tentativi di invasione di coscienza e da opinioni (fatte legge quasi un centinaio di anni fa) che vorrebbero imporsi come su un campo di guerra.
Mi soffermo solo un attimo su questa vicenda, che forse ci può illuminare sugli aspetti riguardanti le prime due notizie.
Per farlo, prendo spunto e commento una lettera al giornale “Avvenire” della Presidente del Movimento per la Vita italiano e docente di Bioetica, Marina Casini Bandini, che scrive [4]: “la vicenda che ha rimesso davanti alla Consulta la costituzionalità dell’art. 580 del codice penale è semplice e chiara: un uomo concorre attivamente a realizzare il gesto suicidario diretto e volontario di un altro uomo, con la pretesa che tale gesto porti il sigillo del 'diritto'.” E già qui ci sarebbe da opinare che non si tratta di gesto, ma di desiderio, e c’è una bella differenza. Ci ritorneremo.
Continua, – “…il reale obiettivo che si vuole raggiungere è chiaro: riconoscere all’individuo la «libertà di decidere quando e come morire», pertanto «solo le azioni che pregiudicano la sua libertà di decisione possono costituire offesa al bene tutelato dalla norma in esame». In realtà, il preteso 'diritto di morire' si scontra con diverse normative che invece affermano la indisponibilità della vita umana sia altrui che propria.”. Eccolo dunque il nocciolo della questione, ci sono norme precise che normano: la nostra vita è a noi indisponibile per legge.
Alla professoressa Bandini comunque la norma non basta, pretende di più. Vuole cercare di ristabilire cosa si intenda per principio di autodeterminazione, libera scelta, dignità umana, principio di uguaglianza e di “autentico e solidaristico legame tra gli uomini”. Il tutto condensato in poche righe di lettera al giornale dove tra l’altro riesce anche a spingersi nelle pieghe della vita privata di dj Fabo: – “Spesso si è detto che Dj Fabo non era solo, che era circondato dall’affetto dei suoi cari lasciando intendere che non era la solitudine o il senso di abbandono ad averlo spinto alla scelta di morire. Non vi è motivo di dubitare della compagnia degli affetti. Però, probabilmente, la solitudine che spinge alla richiesta di morte è qualcosa di profondo e indicibile collegato alla mancanza di senso della propria vita anche alla luce di quanto gli altri ci fanno percepire di noi stessi.”
A questo punto manca solo un ultimo passaggio, eccolo: -“«Si può dimenticare il degrado del proprio corpo se lo sguardo degli altri è pieno di tenerezza», è una frase scritta nelle pagine del diario di un hospice. Siamo tutti collegati e chiamati a questo sguardo carico di tenerezza, a 'custodirci' vicendevolmente nel riconoscimento della uguale dignità della nostra vita.”.
Certo, c’è ancora spazio per un messaggio profetico – “per questo la morte va accettata come inevitabile limite ed esito dell’esistenza terrena […]” – ma vorrei fermarmi al richiamo a “custodirci” espresso dalla professoressa, considerandolo suggestivamente come un altro elemento sincronico, nel nostro discorso. Senza troppe pretese di esegesi.
Nell’invito catechetico non si parla di presenza, ascolto, aiuto, empatia. Il verbo usato rimanda evidentemente a quella “custodia” che è salvaguardia di un oggetto affidato attraverso un’attenta sorveglianza. Parrebbe che la custodia non possa essere che un atto naturale prima ancora che un dovere. Sarebbe perciò scontata, anche nei casi di involontaria mancanza, come sembra sia accaduto e accada nei servizi psichiatrici, una condanna in termini giuridici, se non a questo punto anche morali e dottrinali.
Non possono sussistere distrazioni o attenuanti, nè, guai!, essere tentate considerazioni in merito alla volontà della persona che sceglie l’atto suicidario (sono tutti incapaci di intendere e volere i suicidi?). Perchè la volontà poco conta, anzi non è neanche nella disponibilità legale soggettiva. E visto che per ovvie ragioni non si può condannare il suicida (e chi lo tenta senza riuscirici?), da qualche parte qualcuno legato all'illecito dev'essere trovato, e punito. Non potrebbe essere altrimenti per una società insofferente al vischioso pensiero di poter aver colpa nelle scelte estreme delle sue parti, alla costante ricerca di un capro espiatorio. Ecco quindi che colpevole è chi non impedisce il passaggio all’atto suicida. Tutto semplice e lineare, in fondo basta escludere la realtà. E la sua complessità. Per esempio, non facendo caso alla quantità di intenti suicidari che quotidianamente ascolta uno psichiatra. E ai rischi che lo stesso deve assumersi, nei tempi sempre più ristretti previsti dalla realtà del lavoro, nel decidere se ritenerli “concreti e attuali”, o derubricarli a “modalità manipolativa” e alla solita “ricerca di attenzioni”. E ancora, scotomizzando il fatto che i pensieri di una persona che ha deciso di togliersi la vita spesso non sono rivelati.
La complessità della realtà, della soggettività, dei pensieri, delle volontà, del dolore, della psicopatologia, dei rapporti, delle decisioni, della cura, tutto ciò sembra contare sempre meno. In favore di un dovere custodialistico appunto, che peraltro non si capisce neanche bene chi e come dovrebbe attuare. Spetta solo alla psichiatria la tutela di un potenziale suicida? Bisogna ricoverare e custodire ogni persona che verbalizza un’intenzione autolesiva? E se questa non accetta il ricovero, va attuato un Trattamento Sanitario Obbligatorio? Una volta ricoverato va osservato a vista (spesso il suicidio è un atto impulsivo, per cui le modalità d’azione potrebbero essere improvvise)? Non essendoci ovviamente abbastanza personale per un rapporto uno a uno, vanno attuate delle misure preventive? Immagino quelle coercitive a questo punto, il potenziale suicida va legato a letto fino a quando non contrattualizza la rinuncia alle proprie intenzioni illecite?
Le sentenze non si commentano. Alcuni discorsi si commentano da soli. E allora provo a immaginare. Eccolo, dunque, questo scenario distopico, questo panottico di Bentham dove curanti e curati si origliano e si osservano sospettosi per ogni sussurro, movimento, allusione, ipotesi. Con lo sguardo, sperduto nell’assurdo, dell’uomo davanti alla legge di Kafka. Incapaci di comprendere quale processo sia stato loro intentato. Da una parte il paziente (la persona-soggetto?) che vorrebbe attuare una volontà, illecita, che gli è preclusa, dall’altra l’operatore a cui niente può sfuggire, non nel presente, ma neanche nel futuro. Dunque chiamato a prevedere e presagire, forte della sua scienza (!). Eppure qualunque psichiatra, credo io, direbbe con certezza che sono pochi i casi in cui la volontà può essere davvero abolita da un quadro psicopatologico. Spesso ci sono discussioni anche sul grado di riduzione di tale capacità. Estendere oltre alcuni limiti (disturbi psicotici, affettivi, intellettivi) la questione vuol dire entrare in un terreno ampissimo, quello dell’esistenza umana. Con le sue condizioni purtroppo di dolore e disperazione. Di perdita.
Volontà, possibilità, desiderio, volontà e possibilità di essere desiderati. Riusciamo a confrontarci su questo o la questione si chiude ancora con la riduzione a due verbi, sorvegliare e punire?
Questa società può ancora provare a riflettere sulla sua tanatofobia e sulla sua paranoia? Sulla sua disgregazione e sui motivi per cui i disturbi mentali e la sofferenza in generale sono in costante aumento? Può ancora sospendere il giudizio su ciò che ha creduto ineluttabile e che però sta producendo solo detriti e macerie? Le è rimasto ancora del tempo per pensare agli esiti disumani del processo inarrestabile di marginalizzazione del diverso e a-normale?
Dovremmo rispondere a queste domande prima di pretendere dagli altri di prolungare l'agonia per salvaguardare la nostra coscienza. Dovremmo chiedere, capire, e ottenere condizioni pratiche come l'incremento di operatori di aiuto, prima di condannare. Avere come obiettivi la cooperazione, l'apertura dei servizi, le interferenze positive tra le diverse parti di una società. Altro che sorveglianza, custodia, luoghi chiusi, sbarramenti.
La soluzione alle passioni tristi non si può trovare nel timor mortis e nelle limitazioni della libertà. Nè tantomeno nella paura.
Perciò, dal mio piccolo spazio di operatore, vorrei dire agli altri di oggi e a quelli che decideranno per questa strada, di fare tutto il possibile per rimanere soggetti di aiuto e far rimanere gli altri soggetti di diritto all'aiuto.
Io non voglio custodire.
[2] https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/treviglio-psichiatri-processo-1.3797532
[3] https://www.associazionelucacoscioni.it/appelli/appello-a-gentiloni/
[4] https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/suicidio-assistito-resistenza-necessaria
![]()








0 commenti