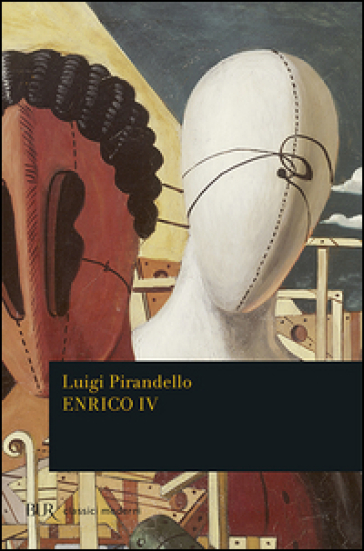 Siamo sicuri che, quando insegniamo a parlare ad un bambino gli rendiamo sempre e necessariamente un buon servizio? La stessa domanda dovremmo porcela quando insegniamo ad un giovane ad esprimersi in modo appropriato, oppure quando aiutiamo un paziente a tradurre in parole quel che sente o quel che pensa. Dice Pirandello, per voce del suo personaggio Enrico IV:
Siamo sicuri che, quando insegniamo a parlare ad un bambino gli rendiamo sempre e necessariamente un buon servizio? La stessa domanda dovremmo porcela quando insegniamo ad un giovane ad esprimersi in modo appropriato, oppure quando aiutiamo un paziente a tradurre in parole quel che sente o quel che pensa. Dice Pirandello, per voce del suo personaggio Enrico IV:
“Tutta la vita è schiacciata dal peso delle parole! Il peso dei morti! (…) Questo giorno che ci sta davanti – voi dite – lo faremo noi! – Sì? Voi? E salutatemi tutte le tradizioni! Salutatemi tutti i costumi! Mettetevi a parlare! Ripeterete tutte le parole che si sono sempre dette! Credete di vivere? Rimasticate la vita dei morti!”
Le parole consentono di passare da un tipo d’esperienza immediata, fatta di sensazioni, ad una in cui è possibile definire ciò che si vive e riflettervi. Tuttavia noi non creiamo i simboli verbali di cui facciamo uso, li ereditiamo dai nostri antenati. Pirandello, almeno quando parla per voce del suo personaggio, ci propone una visione pessimistica: la parola, secondo lui, ci dà solo l’illusione di comprendere e di esprimere quel che siamo individualmente; in realtà, il linguaggio (forgiato dalle tradizioni e dai costumi che ci sono stati tramandati) è il mezzo tramite cui i morti continuano a vivere al posto nostro.
La mia opinione non è altrettanto pessimistica: gli antenati, nostri padri, in quanto ci hanno voluto bene, hanno cercato di favorire una nostra esistenza soggettiva individuale, e non di “vivere al posto nostro”. Solo i genitori (o i regimi) tirannici sono nemici della nostra individualità; solo essi impongono una “neolingua” orwelliana che c’impedisce di capire e di esprimere quel che siamo e ci prescrive un modo di essere che appartiene a loro e non a noi. Quanto descrive Pirandello (con parole diverse, lo fa anche Lacan) è l’imposizione autoritaria di un uso non creativo del linguaggio; un linguaggio che diviene veicolo di estraniazione da sé e d’indottrinamento. Viceversa il genitore (o il regime politico) più sano lascia spazio a rapporti empatici, tesi alla comprensione non di quel che l’individuo “deve” pensare o sentire, ma a quel che effettivamente pensa, desidera, teme; e alla traduzione di quel che si è compreso in parole; parole nuove, se necessario, ma parole che trovino, in ciascuno, un’eco nel suo mondo interno.
![]()








0 commenti