Dove va la psicoanalisi. Alcune riflessioni su "Dislocazioni di Lorena Preta"
3 gennaio, 2019 - 18:59
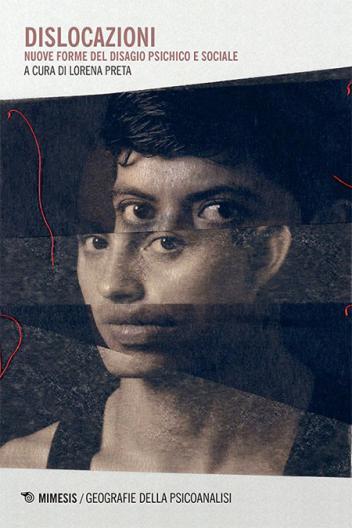
Editore: Mimesis
Anno: 2018
Pagine: 103
Costo: €10.00
Come è noto, per Thomas Kuhn il ritmo della scienza viene scandito dal riordinamento gestaltico dei paradigmi: la scienza non progredirebbe per mezzo di falsificazioni e confutazioni, ma attraverso l’alternarsi di modelli di leggi, teorie, applicazioni e strumenti che caratterizzano una particolare tradizione di ricerca. Secondo l’interpretazione convenzionale dell’intuizione kuhniana, l’instaurazione di un determinato paradigma inaugurerebbe il periodo di cosiddetta scienza normale, un intervallo di bonaccia in cui la ricerca è orientata alla risoluzione di problemi semplici (“rompicapo”) coerenti con il paradigma di riferimento. Tale presunta quiete verrebbe successivamente messa a repentaglio dal progressivo accumulo di contro-evidenze che inficiano il paradigma di riferimento. L’aumento delle anomalie riscontrate, successivamente, potrà innescare una crisi o una vera e propria rivoluzione, evento quest’ultimo che condurrebbe alla sostituzione del paradigma stesso. Ma poiché una simile svolta comporta un complessivo mutamento degli standard metodologici e teorici, nota Kuhn, ne consegue che saranno gli stessi paradigmi (e non semplicemente i loro dati osservativi e sperimentali) a risultare incommensurabili tra loro. Quest’ultimo punto è particolarmente importante, perché nega che esista qualcosa come il Progresso scientifico: dato che i paradigmi sono tra loro non confrontabili, non esiste alcuna visione teleologica dell’accumulo della conoscenza, ma solo un suo riarrangiamento qualitativo.
Da questo assetto particolare conseguono alcune evidenti conclusioni: 1) in primo luogo, per il modello kuhniano non esiste un criterio di neutralità assoluta: ciascun dato di osservazione è intelligibile solo all’interno del quadro interpretativo del paradigma di riferimento 2) non essendovi un dispiegamento lineare dell’accumulo di conoscenza, e poiché il “progresso” si compie per salti tra un paradigma e l’altro, possiamo parlare di vere e proprie rotture epistemologiche 3) ma se il progresso avviene - mutuando un termine neuroscientifico - per “conduzione saltatoria”, è evidente che il ruolo stesso della tradizione debba essere accuratamente ripensato. Anzitutto, è bene notare che nei periodi di ricerca ordinaria (scienza normale) essa tenderà a codificare e interpretare i risultati di ciascuna ricerca unicamente secondo i propri criteri (ovvero seguendo il paradigma in carica in quel preciso momento). In secondo luogo, considerate questa tendenza reazionaria della tradizione e l’incommensurabilità dei paradigmi, il cambiamento radicale (rivoluzione) non potrà che essere percepito ogni volta come stridente rispetto alle logiche del paradigma vigente e, più radicalmente, come ostile e minaccioso. Insomma, anziché costituire il prezioso patrimonio di nozioni, conoscenze e modelli che assicura un punto di vista quanto più obiettivo possibile sui nuovi fenomeni, la tradizione finisce per ridursi ad una cornice interpretativa tra le tante, che di volta in volta esercita la propria pressione reazionaria affinché i nuovi dati si conformino ai precedenti. Per dirla lacanianamente, secondo Kuhn “La tradizione non esiste”, ci sono solo – di volta in volta – tante incommensurabili tradizioni derivanti dai paradigmi.
Quest’ultimo punto in particolare ci aiuta a cogliere la totale divergenza epistemologica che sussiste tra il sistema del filosofo statunitense e, ad esempio, il falsificazionismo di Karl Popper. Come nota Sergio Benvenuto, non si tratta tanto di rendersi conto che “se il falsificazionismo popperiano venisse seguito sul serio nel dibattito scientifico, nessuna teoria (…) dovrebbe essere accettata”[i], quanto di come sia proprio in ciò che il razionalismo di Popper mira a confutare che starebbe la “linfa” del cambiamento, il carburante della scienza. In poche parole, secondo Kuhn ciascuna nuova teoria emerge in un mare di “contro-fatti”, “anomalie” e fenomeni che mirano a confutarla e, in questo senso, il periodo di scienza normale non sarebbe altro che un periodo di tenace normalizzazione, tutt’altro che quieto e ordinario. “In questo modo, a Popper sfugge ciò che si potrebbe chiamare l’economia conservatrice della scienza”[ii], l’idea che la maturazione storica garantita dall’incessante discussione critica rischi di conferire alla scienza una costitutiva trazione posteriore, una tendenza alla conferma che non passa al vaglio critico i criteri che garantiscono le condizioni di possibilità e validità della condotta critica stessa.
Di conseguenza, per dirla alla Slavoj Žižek, la vera rivoluzione non sta tanto in una ridistribuzione delle misure dominanti (fatti che si adeguano o meno ai rispettivi paradigmi), quanto nella sovversione del criterio stesso di misura[iii]. La tendenza kuhniana a “far quadrare i conti” durante il periodo di scienza normale non designa una semplice ginnastica scientifica, l’ordinario esercizio delle nozioni di base desunte dal paradigma, ma lo sforzo attivo di tradurre i meri fatti nella tradizione di turno. Riprendendo per esteso il discorso di Benvenuto: “ogni nuova teoria, proprio in quanto nuova (in quanto non ha avuto cioè il tempo di <<normalizzarsi>> nel corso di un prolungato dibattito scientifico), emerge in un mare di contro-fatti, di anomalie, di fenomeni che la confutano. Occorre il lavoro di talpa, o di formica, degli <<scienziati normali>> - di quelli cioè che accettano una data teoria, o un dato paradigma scientifico, in modo non critico né problematico – affinché la teoria si rinsaldi, generando una serie di sotto-teorie di puntello, scoprendo o sottolineando fatti nuovi che vengono a confermare la loro visione”[iv].
Spostando il focus della nostra analisi, possiamo ora arrivare a chiederci: quanto un simile criterio di rottura epistemologica è applicabile alla psicoanalisi? Ovvero, fino a che punto si può dire che la stessa psicoanalisi, in linea con i paradigmi kuhniani, sia sottoposta ad una simile alternanza di modelli, leggi, teorie? È probabile che tale quesito, spesso e volentieri dimesso dalla teoria psicoanalitica e dalla sua visione della società in cui viviamo, sia oggi più che mai pertinente: non sono forse il post-umano, l’antropocene, le teorie/applicazioni bio-tecnologiche nella loro radicale instabilità epistemologica una specie di “scienza straordinaria” (ovvero di momento di esplicito conflitto tra paradigmi scientifici)?[v] E, a riguardo, fino a che punto e con quali mezzi la psicoanalisi è tenuta ad affrontare criticamente questo ciclone epistemico?
Sempre più autori provenienti da campi del sapere differenti convengono nel notare che oggi più che mai stiamo assistendo ad uno sconvolgimento straordinario, che non ha a che fare con le grandi questioni metafisiche o con le particelle invisibili della fisica quantistica, ma che ci convoca in prima persona: le nuove forme di comunicazione, la gestione dello spazio virtuale e non, la percezione del nostro corpo, il progressivo dis-assemblaggio e ri-assemblaggio della struttura famigliare eccetera. Più nello specifico, ciò che dobbiamo chiederci è: può la psicoanalisi costituire in qualche modo uno strumento (ancora) adatto alla comprensione delle nuove società che si vanno via via evolvendo e formando? L’esempio di Charles Melman, che è stato tra i primi a fornire una risposta alla rottura epistemologica dei millennials, ci dimostra come qualsiasi intervento critico di questo tipo debba passare prima di tutto per uno scrutinio dei propri strumenti, per una valutazione autocritica della propria economia conservatrice. In due importanti e acclamati scritti (L’uomo senza gravità e La nuova economia psichica)[vi], il noto psicoanalista francese ed allievo di Lacan cerca di fornire una risposta allo scadimento dell’attendibilità epistemica del meccanismo edipico. Difatti, da Freud in poi, l’Edipo ha costituito la “pietra angolare della nevrosi”, nonché la principale matrice interpretativa tanto sociale quanto individuale (parafrasando Fachinelli diremmo “nexologica”[vii]) del XX secolo. Per Melman, le soglie del XXI secolo hanno sancito il compimento definitivo dell’evaporazione del Padre simbolico, fenomeno innescato a partire dall’avvento della scienza moderna e dall’intuizione galileiana per cui “il cielo è vuoto” (lacanianamente parlando: il grande Altro non esiste). A questo scadimento clinico e, per così dire, sociologico dell’Edipo, Melman oppone l’avvento di una nicciana società di décadent, soggetti ottusi che non ricercano più il piacere, ma uno stato di costante ed ininterrotta eccitazione. Insomma, la crisi del paradigma edipico sancirebbe la fine di un’economia psichica centrata sul Padre: la perdita dell’ingombro fallico, del peso simbolico della castrazione, lascia il soggetto letteralmente senza appigli, senza zavorre cui tenersi (da qui il titolo de “L’uomo senza gravità”). Quali sono, psicoanaliticamente parlando, i principali effetti di tale destituzione? Anzitutto, dice Melman, la sessualità regredirebbe ad un bisogno (besoin) tra gli altri (“oggi si considera il sesso a titolo di un bisogno, come la fame o la sete”[viii]). Venuto meno l’appiglio simbolico del Padre, la sessualità perde il suo statuto di organizzatore di tutti gli altri godimenti, di loro principio sovradeterminato, e diventa ad essi immanente. Se infatti nella soggettivazione edipica il godimento veniva presentato come rovescio negativo del desiderio, come ricerca di un piacere sempre già barrato/interdetto, con il “declino del Nome del Padre”[ix] è proprio la funzione del limite (castrazione) a venir meno. La seconda tesi di Melman, in accordo con la prima, postula che nella nuova economia psichica si abbia una vera e propria sutura del soggetto diviso: la mancanza viene colmata dalla normalizzazione dell’eccesso e “ciò che ci sembrava essere di troppo, da rifiutare, è ora normale”.[x]
Nella sua critica all’edonismo diffuso e ininterrotto e denunciando il collasso del godimento edipico, Melman si scaglia contro l’attuale economia liberale Occidentale, la cui ideologia “mira a far saltare tutti i limiti della soddisfazione e del godimento”[xi] e a in-differenziare quest’ultimo nel mare magnum del politically correct (“nessuno ha il diritto di criticare nessun tipo di godimento. Se lo fate, diventate politicamente scorretti”[xii]).
Eppure, uno dei problemi della posizione di Melman è che essa risiede su una (latente) presunta sessualità normativa, in qualche modo logicamente superiore e maggiormente organizzata rispetto alle pulsioni parziali pre-edipiche. Ciò che di conseguenza viene meno è il modo in cui questi piaceri sessuali “grezzi”, cui la sessualità edipica regredirebbe, siano essi stessi informati non tanto dalla sessualità genitale post-edipica, quanto dalla sua assenza, dal fatto che “non c’è rapporto sessuale”. L’eccessiva enfasi posta da Melman sulla sessualità organica ed ordinata perduta dai millennials e sostituita da una gorgonica normativa matriarcale dimentica che non solamente le singole pulsioni parziali costituiscono la concretizzazione di un puro negativo (ovvero l’epitome reale dell’assenza di una sessualità convenzionale e sociale), ma che la sessualità stessa è questo negativo, un inemendabile vuoto ontologico. A parte questo contrappunto lacaniano, il principale problema di tale “nuova economia psichica”, in linea con quanto detto sinora, è la tendenza a concepire la trasformazione (storica) del paradigma edipico in termini aprioristicamente catastrofici. Come a dire, al di là dell’Edipo non può che regnare un caos perverso polimorfo. Difatti, non solo Melman arriva a patologizzare esplicitamente l’intera società occidentale, condannata senza appello ad un edonismo dissipativo e senza ideali, ma si dimostra anche incapace di fornire una via di uscita da questo scenario di complessiva e chiassosa impotenza.
Insomma, sembrerebbe che lo psicoanalista francese confuti e rifiuti proprio ciò che costituisce, nel passaggio dal paradigma edipico ad una nuova economia psichica, il criterio di rottura epistemologica di cui abbiamo parlato poco fa. Il rischio (non solo) teoretico di una simile scelta non è solo quello di vedere il futuro – ciò che non si conforma alla tradizione/paradigma - come foriero di catastrofi e impoverimenti, ma anche di degenerare in uno sconveniente “discorso di fine della storia”: parafrasando Lorenzo Chiesa, perché l’inadeguatezza dell’Edipo (o la rivoluzione digitale, o l’avvento delle biotecnologie, o la virtualizzazione dello spazio) dovrebbe per forza di cose catapultarci in una specie di post-storia post-psicoanalitica?[xiii] Emerge come il rischio di una teoria che voglia colmare in modo onnicomprensivo i vuoti lasciati aperti dal salto di paradigma (le cosiddette perdite kuhniane) alla transizione socio-antropo-logica odierna sia quello di rovesciarsi in un mero e francamente inutile nichilismo. In generale, ritengo quella di Melman una tesi “ideologicamente coinvolta” nel senso badusiano del termine: il suo coefficiente ideologico non rimanda ad uno specifico contenuto concreto e positivo (un ideale), ma si compone di una critica radicale che bolla di utopismo ogni tentativo di approccio al proprio oggetto. Oggi, essere preda dell’ideologia non vuole più dire credere in qualche ideale astratto e trascendentale, ma semmai il contrario: affidarsi ciecamente alla cinica rassegnazione che nessun cambiamento sia possibile. Come scrive Žižek, “la principale funzione della censura ideologica non è di contrastare una qualche resistenza effettiva, reale (…) ma di reprimere la speranza.”[xiv]
Con questo ampio preambolo, posso arrivare a dire che trovo invece la proposta avanzata da Lorena Preta, per quanto meno ambiziosa, certamente più meritevole di attenzione e maggiormente stimolante per le prospettive future: attualmente, non stiamo avendo a che fare con un collasso catastrofico della soggettività, ma piuttosto con una sua dislocazione. Nonostante la concezione di un vero e proprio “soggetto dislocato” suggerisca alcune problematicità di fondo (ad esempio, quale sarebbe la specifica portata clinica di una simile soggettività? E in che modo quest’ultima dovrebbe realmente sottrarsi al rischio melmaniano di una patologizzazione totale?), trovo che la strategia teorica di Preta favorisca una maggior permeabilità all’attuale presunto momento di rottura epistemologica che stiamo vivendo. Anzitutto perché non chiude le frontiere psicoanalitiche al dialogo con altri campi e discipline (e il libro che qui di seguito vado a presentare ne è una prova), in secondo luogo perché questo approccio, lungi dal dichiararsi una mera e impotente critica per la critica, cerca di articolare i presupposti di base per una prospettiva di intervento clinico effettivo.
In particolare, l’autrice avanza questa sua originale ipotesi in Dislocazioni (Mimesis, 2018, 106 pp.), testo collettaneo che raccoglie sette contributi accomunati dall’intento di ridefinire un campo di azione e di elaborazione in cui la psicoanalisi possa fungere da effettivo strumento (tanto critico quanto applicativo) rispetto ai nuovi fenomeni socio-simbolici del secondo millennio. Dei sette saggi riportati, desidero considerarne due in particolare, altamente indicativi della andatura complessiva del libro.
Il contributo di Vittorio Lingiardi ad esempio (Senza mappe per questi territori) si propone di rispondere al noto e provocatorio quesito di André Green circa la pertinenza del sessuale rispetto alla psicoanalisi (“La sessualità ha qualcosa a che vedere con la psicoanalisi?”), convocando a sé le attuali frontiere del campo clinico e teorico psicoanalitico (e non solo). L’approccio interdisciplinare, assimilazionista e anti-sostanzialista di Lingiardi, decisamente alieno alla segregazione conservatrice (“la mia generazione è ancora segnata (talora sfregiata) da certezze psicoanalitiche troppo spesso intrecciate con la convinzione che la psicoanalisi debba promuovere percorsi e valori predefiniti”[xv]), ci mostra un punto di vista dialettico sulla psicoanalisi e sulla teoria di genere che prescinde dall’aut-aut essenzialismo/culturalismo e fa della sessualità un “organizzatore potente dell’esperienza (psichica)” che attinge tanto dai risultati performativi del genere sessuale (“qualcosa che facciamo, piuttosto che qualcosa che siamo”[xvi]), quanto dal mosaico caleidoscopico dell’inconscio, “in cui elementi con forme e densità diverse si organizzano in strutture uniche determinate da percorsi relazionali infiniti”[xvii]. Il monito etico del saggio allora, al di là delle forbite documentazioni cliniche cui l’autore fa appello (dai vari approcci all’omosessualità nel corso della storia della psicoanalisi sino alle evidenze empiriche della teoria dell’attaccamento), invita lo psicoanalista a schiudere una zona di elaborazione in-between che sappia dialogare tanto con la tradizione teorica (paradigmatica) precedente, quanto elaborare le nuove esigenze antropologiche della società post-edipica in chiave attuale. Insomma, per Lingiardi si tratterebbe di cogliere le singolarità e le contingenze di ogni condizione clinica sullo sfondo di una continua “oscillazione [dialettica] tra il relativo e l’assoluto”, “l’individuale e il sociale”[xviii], tenendo sempre presente sullo sfondo il mantra per cui “tutto ciò che si irrigidisce in modo perenne delle nostre attitudini deve diventare fluido; tutto ciò che galleggia in modo precario e incerto deve essere ancorato.”[xix]
Il saggio di Gohar Homayounpour (Esperienze di transgenderismo in Iran) invece, attingendo dalla letteratura e dall’esperienza clinica transgender, esordisce con un assioma (oltre che un dato di fatto) assai vicino alla psicoanalisi lacaniana: la piena soddisfazione sessuale non esiste. Sarebbe a dire che, fintantoché avremo a che fare con la sessualità, al di là di interferenze o di schermi buonisti, dovremo fare i conti con qualcosa di costitutivamente problematico. Anzi, possiamo persino arrivare a dire che, citando la filosofa slovena Alenka Zupančič, “ciò che Freud chiama sessuale non è (…) ciò che ci rende umani (…) ma ciò che ci rende soggetti, o forse più precisamente è coestensivo con l’emergere del soggetto”[xx]. Servendosi di un utile supporto statistico, l’autore riporta il caso specifico della Disforia di Genere e dei relativi interventi di riattribuzione chirurgica del sesso (SRS) che stanno avvenendo con crescente occorrenza in Iran. L’Iran, ci spiega Homayounpour, costituisce un significativo esempio geopolitico, in quanto si tratta di una nazione conservatrice (di legge islamica) che cerca di portare avanti una gestione superficialmente liberale: secondo questa politica, la contraddizione tra identità di genere e sessualità non si risolverebbe tramite una soggettivazione/elaborazione delle proprie inclinazioni singolari, ma attraverso la conformazione chirurgica reale al genere sessuale.
Al contrario invece, il caso dei transgender (nosograficamente categorizzato nella problematica etichetta di Disforia di Genere[xxi]) costituisce la prova parossistica di come ciascun tentativo di “porre rimedio” alla non corrispondenza tra sessualità e genere non possa che rivelarsi fallimentare. Non esiste alcun intervento normativo sulla sessualità umana, proprio perché nella sessualità “c’è sempre qualcosa che manca (…), qualcosa di [intrinsecamente] sbagliato”[xxii]. La tecnologia avrebbe recentemente reso possibile la fluidificazione della dicotomia di genere (maschile o femminile), favorendo il transito da un’identità sessuale all’altra. Eppure, la clinica evidenzia che questo accrescimento scientifico, pur favorendo il cambiamento di sesso, non sia riuscito a dare risposta alla domanda fondamentale, che mina alla base l’esistenzialismo di questi soggetti: “Cosa rende uomo un uomo e donna una donna?”[xxiii]. Su questa falsariga, e dopo aver riportato tre diversi tipi di testimonianze sull’argomento, Homayounpour conclude lanciando un appello autocritico alla stessa psicoanalisi, la quale per prima, indugiando nel politicamente corretto, sta dimostrando la propria incapacità di prescindere da “un approccio eteronormativo, binario e uniformante”[xxiv]. Per poter approcciare adeguatamente la sessualità, senza ridurla ad un oggetto noto o ad un insieme di pratiche o significati essenziali, c’è bisogno che la psicoanalisi – che “non è mai stata politicamente corretta”[xxv] rimarca Homayounpour – si mantenga sovversiva, anziché coestensiva all’opinione pubblica.
Più nello specifico, ma senza mai prescindere dalla cornice concettuale del resto dei saggi, la dislocazione che ci illustra Lorena Preta è una metafora che racchiude efficacemente l’intera fenomenologia del nuovo destino della psicoanalisi. Come scrive l’autrice, primo ad essere dislocato - e intaccato dall’insufficienza simbolica sancita dell’evaporazione del Padre - è il corpo, “in quanto esiste la tendenza a spostare su di esso le problematiche che dovrebbero poggiare su un’elaborazione psichica.”[xxvi] Lungi dal dipingere uno scenario di cinico edonismo, Preta si concentra sul modo in cui la disregolazione tra la società e i soggetti del nuovo millennio si esperisca sotto forma di un disagio la cui espressività è “molteplice e complessa”, scavata tra i lividi del corpo. Ma, a ragione, l’autore considera anche il rovescio produttivo di questa odierna accelerazione della società e dei suoi effetti sulla psiche dell’individuo: se è vero che da un lato il corpo diviene portatore di tutto ciò che non è elaborato, tanto da rischiare – nei casi più gravi – di finire confinato “in uno spazio visionario dove tutte le attribuzioni sono possibili”, dall’altro “anche le ricerche neurobiologiche ci descrivono una mente plastica in continua ridefinizione rispetto alle fasi dello sviluppo e all’ambiente circostante, capace di organizzare moduli comunicativi altamente differenziati”[xxvii].
In secondo luogo, e potremmo dire in contro-tendenza rispetto a Melman, più che marginalizzata o schiacciata sugli altri godimenti, la sessualità è oggi per Preta, oltre che “dislocata”, anche “dislocante”, mai sintetizzabile in un significato univoco, ma sempre decostruttiva, “capace di spiazzare continuamente l’ovvietà delle visioni condivise del sociale.”[xxviii]
In ultimo, ad essere dislocata (e non preclusa) è la proibizione/interdizione, la condizione di limite che costituisce (ed è la condizione affinché vi sia) il desiderio: la questione, insomma, non sta nel proclamare la piatta ed indifferenziata mono-dimensionalità dei godimenti tutti uguali, ma nello scovare dove questa nuova logica del desiderio, questa nuova economia psichica, si situi. Si tratta insomma di cogliere un punto di elaborazione che possa conciliare il chiasma contraddittorio di “una cultura che esalta la <<parzialità>>” ma che, al tempo stesso, “sacrifica l’idea (…) di <<interezza>>”[xxix].
Per qualificare il senso di decentramento odierno, Preta avanza l’idea di un cortocircuito nell’interazione tra la singolarità psichica e il sistema sociale, un’indistinzione tra il mondo interno e quello esterno che si risolve nella “tendenza ad agire l’inconscio”[xxx] attraverso l’evacuazione di frammenti e detriti mentali non elaborati, di cui la cifra più significativa sarebbe proprio l’alessitimia. Questo tipo di configurazione psicopatologica, che alla lettera vuole dire “mancanza di parole per le emozioni”, costituisce la manifestazione principale dello schiacciamento della dimensione immaginaria su quella Reale, del ritiro della capacità di articolazione/elaborazione simbolica, che rende “impossibile” oppure “allucinata” qualsiasi adesione emotiva alla realtà. Sebbene in certi punti il discorso di Preta rischi di degenerare nel “discorso di fine della storia” esaminato poco fa (ad esempio quando nell’Introduzione parla di “una frammentazione disgregante che sembra legata alla pulsione di morte”[xxxi] oppure quando descrive un disarcionamento radicale tra il passato e il presente delle nuove generazioni), trovo nel complesso la sua capacità di de-posizionare la soggettività rispetto alla disarticolazione di ogni frontiera prodotta dalla globalizzazione soddisfacente. Specie quando descrive questo “nuovo soggetto” come “portatore di trasformazioni difficili da misurare [ma non per questo non misurabili] nella loro portata (…), un nuovo individuo, un ibrido, frutto della combinazione di diverse culture.”[xxxii]
Propongo in conclusione di leggere l’evocazione amletica (“Il tempo è fuori dai cardini”) fatta da Preta verso la conclusione del libro non come la spaesante constatazione di un inevitabile deragliamento (morale, simbolico, umanitario ecc.), ma come una vera e propria immagine di kuhniana rottura epistemologica. Del resto, non è forse vero che Gilles Deleuze, nelle Lezioni su Kant, accoglieva la stessa formula per indicare la cessazione del tempo ciclico, cosmologico in favore di una pura ed inaudita forma di tempo dispiegato? Come puntualizza il filosofo francese, questo tipo di decentramento vuol dire anche e anzitutto non essere più “subordinat[i] a qualcosa di altro da se stess[i]”[xxxiii], non essere più preda di un paradigma ormai inadeguato a rispondere degli effetti che la realtà produce sulla nostra ossatura simbolica. Del resto, la rivoluzione freudiana non è stata essa stessa, nella sua radicalità, un inaudito decentramento? Non è stato forse l’avvento dell’inconscio un mettere fuori di sesto l’idea di un soggetto autoriflesso, totalmente trasparente a se stesso e, con esso, quello di una sessualità scandalosa e bestiale?
Insomma, quando Preta afferma che “non è possibile patologizzare questi fenomeni [ma è necessario] creare un tempo <<into the joint>>” ho l’impressione che arrivi a dire che ciò con cui abbiamo a che fare non è attribuibile ipso facto ad una dislocazione unicamente del soggetto, ma anche a quella della stessa psicoanalisi, che oggi più che mai, se vuole resistere senza tradire i propri presupposti, è convocata a rinsaldare i propri cardini, a ri-articolare la propria prospettiva sul mondo che cambia.
Bibliografia
Benvenuto S.
Da questo assetto particolare conseguono alcune evidenti conclusioni: 1) in primo luogo, per il modello kuhniano non esiste un criterio di neutralità assoluta: ciascun dato di osservazione è intelligibile solo all’interno del quadro interpretativo del paradigma di riferimento 2) non essendovi un dispiegamento lineare dell’accumulo di conoscenza, e poiché il “progresso” si compie per salti tra un paradigma e l’altro, possiamo parlare di vere e proprie rotture epistemologiche 3) ma se il progresso avviene - mutuando un termine neuroscientifico - per “conduzione saltatoria”, è evidente che il ruolo stesso della tradizione debba essere accuratamente ripensato. Anzitutto, è bene notare che nei periodi di ricerca ordinaria (scienza normale) essa tenderà a codificare e interpretare i risultati di ciascuna ricerca unicamente secondo i propri criteri (ovvero seguendo il paradigma in carica in quel preciso momento). In secondo luogo, considerate questa tendenza reazionaria della tradizione e l’incommensurabilità dei paradigmi, il cambiamento radicale (rivoluzione) non potrà che essere percepito ogni volta come stridente rispetto alle logiche del paradigma vigente e, più radicalmente, come ostile e minaccioso. Insomma, anziché costituire il prezioso patrimonio di nozioni, conoscenze e modelli che assicura un punto di vista quanto più obiettivo possibile sui nuovi fenomeni, la tradizione finisce per ridursi ad una cornice interpretativa tra le tante, che di volta in volta esercita la propria pressione reazionaria affinché i nuovi dati si conformino ai precedenti. Per dirla lacanianamente, secondo Kuhn “La tradizione non esiste”, ci sono solo – di volta in volta – tante incommensurabili tradizioni derivanti dai paradigmi.
Quest’ultimo punto in particolare ci aiuta a cogliere la totale divergenza epistemologica che sussiste tra il sistema del filosofo statunitense e, ad esempio, il falsificazionismo di Karl Popper. Come nota Sergio Benvenuto, non si tratta tanto di rendersi conto che “se il falsificazionismo popperiano venisse seguito sul serio nel dibattito scientifico, nessuna teoria (…) dovrebbe essere accettata”[i], quanto di come sia proprio in ciò che il razionalismo di Popper mira a confutare che starebbe la “linfa” del cambiamento, il carburante della scienza. In poche parole, secondo Kuhn ciascuna nuova teoria emerge in un mare di “contro-fatti”, “anomalie” e fenomeni che mirano a confutarla e, in questo senso, il periodo di scienza normale non sarebbe altro che un periodo di tenace normalizzazione, tutt’altro che quieto e ordinario. “In questo modo, a Popper sfugge ciò che si potrebbe chiamare l’economia conservatrice della scienza”[ii], l’idea che la maturazione storica garantita dall’incessante discussione critica rischi di conferire alla scienza una costitutiva trazione posteriore, una tendenza alla conferma che non passa al vaglio critico i criteri che garantiscono le condizioni di possibilità e validità della condotta critica stessa.
Di conseguenza, per dirla alla Slavoj Žižek, la vera rivoluzione non sta tanto in una ridistribuzione delle misure dominanti (fatti che si adeguano o meno ai rispettivi paradigmi), quanto nella sovversione del criterio stesso di misura[iii]. La tendenza kuhniana a “far quadrare i conti” durante il periodo di scienza normale non designa una semplice ginnastica scientifica, l’ordinario esercizio delle nozioni di base desunte dal paradigma, ma lo sforzo attivo di tradurre i meri fatti nella tradizione di turno. Riprendendo per esteso il discorso di Benvenuto: “ogni nuova teoria, proprio in quanto nuova (in quanto non ha avuto cioè il tempo di <<normalizzarsi>> nel corso di un prolungato dibattito scientifico), emerge in un mare di contro-fatti, di anomalie, di fenomeni che la confutano. Occorre il lavoro di talpa, o di formica, degli <<scienziati normali>> - di quelli cioè che accettano una data teoria, o un dato paradigma scientifico, in modo non critico né problematico – affinché la teoria si rinsaldi, generando una serie di sotto-teorie di puntello, scoprendo o sottolineando fatti nuovi che vengono a confermare la loro visione”[iv].
Spostando il focus della nostra analisi, possiamo ora arrivare a chiederci: quanto un simile criterio di rottura epistemologica è applicabile alla psicoanalisi? Ovvero, fino a che punto si può dire che la stessa psicoanalisi, in linea con i paradigmi kuhniani, sia sottoposta ad una simile alternanza di modelli, leggi, teorie? È probabile che tale quesito, spesso e volentieri dimesso dalla teoria psicoanalitica e dalla sua visione della società in cui viviamo, sia oggi più che mai pertinente: non sono forse il post-umano, l’antropocene, le teorie/applicazioni bio-tecnologiche nella loro radicale instabilità epistemologica una specie di “scienza straordinaria” (ovvero di momento di esplicito conflitto tra paradigmi scientifici)?[v] E, a riguardo, fino a che punto e con quali mezzi la psicoanalisi è tenuta ad affrontare criticamente questo ciclone epistemico?
Sempre più autori provenienti da campi del sapere differenti convengono nel notare che oggi più che mai stiamo assistendo ad uno sconvolgimento straordinario, che non ha a che fare con le grandi questioni metafisiche o con le particelle invisibili della fisica quantistica, ma che ci convoca in prima persona: le nuove forme di comunicazione, la gestione dello spazio virtuale e non, la percezione del nostro corpo, il progressivo dis-assemblaggio e ri-assemblaggio della struttura famigliare eccetera. Più nello specifico, ciò che dobbiamo chiederci è: può la psicoanalisi costituire in qualche modo uno strumento (ancora) adatto alla comprensione delle nuove società che si vanno via via evolvendo e formando? L’esempio di Charles Melman, che è stato tra i primi a fornire una risposta alla rottura epistemologica dei millennials, ci dimostra come qualsiasi intervento critico di questo tipo debba passare prima di tutto per uno scrutinio dei propri strumenti, per una valutazione autocritica della propria economia conservatrice. In due importanti e acclamati scritti (L’uomo senza gravità e La nuova economia psichica)[vi], il noto psicoanalista francese ed allievo di Lacan cerca di fornire una risposta allo scadimento dell’attendibilità epistemica del meccanismo edipico. Difatti, da Freud in poi, l’Edipo ha costituito la “pietra angolare della nevrosi”, nonché la principale matrice interpretativa tanto sociale quanto individuale (parafrasando Fachinelli diremmo “nexologica”[vii]) del XX secolo. Per Melman, le soglie del XXI secolo hanno sancito il compimento definitivo dell’evaporazione del Padre simbolico, fenomeno innescato a partire dall’avvento della scienza moderna e dall’intuizione galileiana per cui “il cielo è vuoto” (lacanianamente parlando: il grande Altro non esiste). A questo scadimento clinico e, per così dire, sociologico dell’Edipo, Melman oppone l’avvento di una nicciana società di décadent, soggetti ottusi che non ricercano più il piacere, ma uno stato di costante ed ininterrotta eccitazione. Insomma, la crisi del paradigma edipico sancirebbe la fine di un’economia psichica centrata sul Padre: la perdita dell’ingombro fallico, del peso simbolico della castrazione, lascia il soggetto letteralmente senza appigli, senza zavorre cui tenersi (da qui il titolo de “L’uomo senza gravità”). Quali sono, psicoanaliticamente parlando, i principali effetti di tale destituzione? Anzitutto, dice Melman, la sessualità regredirebbe ad un bisogno (besoin) tra gli altri (“oggi si considera il sesso a titolo di un bisogno, come la fame o la sete”[viii]). Venuto meno l’appiglio simbolico del Padre, la sessualità perde il suo statuto di organizzatore di tutti gli altri godimenti, di loro principio sovradeterminato, e diventa ad essi immanente. Se infatti nella soggettivazione edipica il godimento veniva presentato come rovescio negativo del desiderio, come ricerca di un piacere sempre già barrato/interdetto, con il “declino del Nome del Padre”[ix] è proprio la funzione del limite (castrazione) a venir meno. La seconda tesi di Melman, in accordo con la prima, postula che nella nuova economia psichica si abbia una vera e propria sutura del soggetto diviso: la mancanza viene colmata dalla normalizzazione dell’eccesso e “ciò che ci sembrava essere di troppo, da rifiutare, è ora normale”.[x]
Nella sua critica all’edonismo diffuso e ininterrotto e denunciando il collasso del godimento edipico, Melman si scaglia contro l’attuale economia liberale Occidentale, la cui ideologia “mira a far saltare tutti i limiti della soddisfazione e del godimento”[xi] e a in-differenziare quest’ultimo nel mare magnum del politically correct (“nessuno ha il diritto di criticare nessun tipo di godimento. Se lo fate, diventate politicamente scorretti”[xii]).
Eppure, uno dei problemi della posizione di Melman è che essa risiede su una (latente) presunta sessualità normativa, in qualche modo logicamente superiore e maggiormente organizzata rispetto alle pulsioni parziali pre-edipiche. Ciò che di conseguenza viene meno è il modo in cui questi piaceri sessuali “grezzi”, cui la sessualità edipica regredirebbe, siano essi stessi informati non tanto dalla sessualità genitale post-edipica, quanto dalla sua assenza, dal fatto che “non c’è rapporto sessuale”. L’eccessiva enfasi posta da Melman sulla sessualità organica ed ordinata perduta dai millennials e sostituita da una gorgonica normativa matriarcale dimentica che non solamente le singole pulsioni parziali costituiscono la concretizzazione di un puro negativo (ovvero l’epitome reale dell’assenza di una sessualità convenzionale e sociale), ma che la sessualità stessa è questo negativo, un inemendabile vuoto ontologico. A parte questo contrappunto lacaniano, il principale problema di tale “nuova economia psichica”, in linea con quanto detto sinora, è la tendenza a concepire la trasformazione (storica) del paradigma edipico in termini aprioristicamente catastrofici. Come a dire, al di là dell’Edipo non può che regnare un caos perverso polimorfo. Difatti, non solo Melman arriva a patologizzare esplicitamente l’intera società occidentale, condannata senza appello ad un edonismo dissipativo e senza ideali, ma si dimostra anche incapace di fornire una via di uscita da questo scenario di complessiva e chiassosa impotenza.
Insomma, sembrerebbe che lo psicoanalista francese confuti e rifiuti proprio ciò che costituisce, nel passaggio dal paradigma edipico ad una nuova economia psichica, il criterio di rottura epistemologica di cui abbiamo parlato poco fa. Il rischio (non solo) teoretico di una simile scelta non è solo quello di vedere il futuro – ciò che non si conforma alla tradizione/paradigma - come foriero di catastrofi e impoverimenti, ma anche di degenerare in uno sconveniente “discorso di fine della storia”: parafrasando Lorenzo Chiesa, perché l’inadeguatezza dell’Edipo (o la rivoluzione digitale, o l’avvento delle biotecnologie, o la virtualizzazione dello spazio) dovrebbe per forza di cose catapultarci in una specie di post-storia post-psicoanalitica?[xiii] Emerge come il rischio di una teoria che voglia colmare in modo onnicomprensivo i vuoti lasciati aperti dal salto di paradigma (le cosiddette perdite kuhniane) alla transizione socio-antropo-logica odierna sia quello di rovesciarsi in un mero e francamente inutile nichilismo. In generale, ritengo quella di Melman una tesi “ideologicamente coinvolta” nel senso badusiano del termine: il suo coefficiente ideologico non rimanda ad uno specifico contenuto concreto e positivo (un ideale), ma si compone di una critica radicale che bolla di utopismo ogni tentativo di approccio al proprio oggetto. Oggi, essere preda dell’ideologia non vuole più dire credere in qualche ideale astratto e trascendentale, ma semmai il contrario: affidarsi ciecamente alla cinica rassegnazione che nessun cambiamento sia possibile. Come scrive Žižek, “la principale funzione della censura ideologica non è di contrastare una qualche resistenza effettiva, reale (…) ma di reprimere la speranza.”[xiv]
Con questo ampio preambolo, posso arrivare a dire che trovo invece la proposta avanzata da Lorena Preta, per quanto meno ambiziosa, certamente più meritevole di attenzione e maggiormente stimolante per le prospettive future: attualmente, non stiamo avendo a che fare con un collasso catastrofico della soggettività, ma piuttosto con una sua dislocazione. Nonostante la concezione di un vero e proprio “soggetto dislocato” suggerisca alcune problematicità di fondo (ad esempio, quale sarebbe la specifica portata clinica di una simile soggettività? E in che modo quest’ultima dovrebbe realmente sottrarsi al rischio melmaniano di una patologizzazione totale?), trovo che la strategia teorica di Preta favorisca una maggior permeabilità all’attuale presunto momento di rottura epistemologica che stiamo vivendo. Anzitutto perché non chiude le frontiere psicoanalitiche al dialogo con altri campi e discipline (e il libro che qui di seguito vado a presentare ne è una prova), in secondo luogo perché questo approccio, lungi dal dichiararsi una mera e impotente critica per la critica, cerca di articolare i presupposti di base per una prospettiva di intervento clinico effettivo.
In particolare, l’autrice avanza questa sua originale ipotesi in Dislocazioni (Mimesis, 2018, 106 pp.), testo collettaneo che raccoglie sette contributi accomunati dall’intento di ridefinire un campo di azione e di elaborazione in cui la psicoanalisi possa fungere da effettivo strumento (tanto critico quanto applicativo) rispetto ai nuovi fenomeni socio-simbolici del secondo millennio. Dei sette saggi riportati, desidero considerarne due in particolare, altamente indicativi della andatura complessiva del libro.
Il contributo di Vittorio Lingiardi ad esempio (Senza mappe per questi territori) si propone di rispondere al noto e provocatorio quesito di André Green circa la pertinenza del sessuale rispetto alla psicoanalisi (“La sessualità ha qualcosa a che vedere con la psicoanalisi?”), convocando a sé le attuali frontiere del campo clinico e teorico psicoanalitico (e non solo). L’approccio interdisciplinare, assimilazionista e anti-sostanzialista di Lingiardi, decisamente alieno alla segregazione conservatrice (“la mia generazione è ancora segnata (talora sfregiata) da certezze psicoanalitiche troppo spesso intrecciate con la convinzione che la psicoanalisi debba promuovere percorsi e valori predefiniti”[xv]), ci mostra un punto di vista dialettico sulla psicoanalisi e sulla teoria di genere che prescinde dall’aut-aut essenzialismo/culturalismo e fa della sessualità un “organizzatore potente dell’esperienza (psichica)” che attinge tanto dai risultati performativi del genere sessuale (“qualcosa che facciamo, piuttosto che qualcosa che siamo”[xvi]), quanto dal mosaico caleidoscopico dell’inconscio, “in cui elementi con forme e densità diverse si organizzano in strutture uniche determinate da percorsi relazionali infiniti”[xvii]. Il monito etico del saggio allora, al di là delle forbite documentazioni cliniche cui l’autore fa appello (dai vari approcci all’omosessualità nel corso della storia della psicoanalisi sino alle evidenze empiriche della teoria dell’attaccamento), invita lo psicoanalista a schiudere una zona di elaborazione in-between che sappia dialogare tanto con la tradizione teorica (paradigmatica) precedente, quanto elaborare le nuove esigenze antropologiche della società post-edipica in chiave attuale. Insomma, per Lingiardi si tratterebbe di cogliere le singolarità e le contingenze di ogni condizione clinica sullo sfondo di una continua “oscillazione [dialettica] tra il relativo e l’assoluto”, “l’individuale e il sociale”[xviii], tenendo sempre presente sullo sfondo il mantra per cui “tutto ciò che si irrigidisce in modo perenne delle nostre attitudini deve diventare fluido; tutto ciò che galleggia in modo precario e incerto deve essere ancorato.”[xix]
Il saggio di Gohar Homayounpour (Esperienze di transgenderismo in Iran) invece, attingendo dalla letteratura e dall’esperienza clinica transgender, esordisce con un assioma (oltre che un dato di fatto) assai vicino alla psicoanalisi lacaniana: la piena soddisfazione sessuale non esiste. Sarebbe a dire che, fintantoché avremo a che fare con la sessualità, al di là di interferenze o di schermi buonisti, dovremo fare i conti con qualcosa di costitutivamente problematico. Anzi, possiamo persino arrivare a dire che, citando la filosofa slovena Alenka Zupančič, “ciò che Freud chiama sessuale non è (…) ciò che ci rende umani (…) ma ciò che ci rende soggetti, o forse più precisamente è coestensivo con l’emergere del soggetto”[xx]. Servendosi di un utile supporto statistico, l’autore riporta il caso specifico della Disforia di Genere e dei relativi interventi di riattribuzione chirurgica del sesso (SRS) che stanno avvenendo con crescente occorrenza in Iran. L’Iran, ci spiega Homayounpour, costituisce un significativo esempio geopolitico, in quanto si tratta di una nazione conservatrice (di legge islamica) che cerca di portare avanti una gestione superficialmente liberale: secondo questa politica, la contraddizione tra identità di genere e sessualità non si risolverebbe tramite una soggettivazione/elaborazione delle proprie inclinazioni singolari, ma attraverso la conformazione chirurgica reale al genere sessuale.
Al contrario invece, il caso dei transgender (nosograficamente categorizzato nella problematica etichetta di Disforia di Genere[xxi]) costituisce la prova parossistica di come ciascun tentativo di “porre rimedio” alla non corrispondenza tra sessualità e genere non possa che rivelarsi fallimentare. Non esiste alcun intervento normativo sulla sessualità umana, proprio perché nella sessualità “c’è sempre qualcosa che manca (…), qualcosa di [intrinsecamente] sbagliato”[xxii]. La tecnologia avrebbe recentemente reso possibile la fluidificazione della dicotomia di genere (maschile o femminile), favorendo il transito da un’identità sessuale all’altra. Eppure, la clinica evidenzia che questo accrescimento scientifico, pur favorendo il cambiamento di sesso, non sia riuscito a dare risposta alla domanda fondamentale, che mina alla base l’esistenzialismo di questi soggetti: “Cosa rende uomo un uomo e donna una donna?”[xxiii]. Su questa falsariga, e dopo aver riportato tre diversi tipi di testimonianze sull’argomento, Homayounpour conclude lanciando un appello autocritico alla stessa psicoanalisi, la quale per prima, indugiando nel politicamente corretto, sta dimostrando la propria incapacità di prescindere da “un approccio eteronormativo, binario e uniformante”[xxiv]. Per poter approcciare adeguatamente la sessualità, senza ridurla ad un oggetto noto o ad un insieme di pratiche o significati essenziali, c’è bisogno che la psicoanalisi – che “non è mai stata politicamente corretta”[xxv] rimarca Homayounpour – si mantenga sovversiva, anziché coestensiva all’opinione pubblica.
Più nello specifico, ma senza mai prescindere dalla cornice concettuale del resto dei saggi, la dislocazione che ci illustra Lorena Preta è una metafora che racchiude efficacemente l’intera fenomenologia del nuovo destino della psicoanalisi. Come scrive l’autrice, primo ad essere dislocato - e intaccato dall’insufficienza simbolica sancita dell’evaporazione del Padre - è il corpo, “in quanto esiste la tendenza a spostare su di esso le problematiche che dovrebbero poggiare su un’elaborazione psichica.”[xxvi] Lungi dal dipingere uno scenario di cinico edonismo, Preta si concentra sul modo in cui la disregolazione tra la società e i soggetti del nuovo millennio si esperisca sotto forma di un disagio la cui espressività è “molteplice e complessa”, scavata tra i lividi del corpo. Ma, a ragione, l’autore considera anche il rovescio produttivo di questa odierna accelerazione della società e dei suoi effetti sulla psiche dell’individuo: se è vero che da un lato il corpo diviene portatore di tutto ciò che non è elaborato, tanto da rischiare – nei casi più gravi – di finire confinato “in uno spazio visionario dove tutte le attribuzioni sono possibili”, dall’altro “anche le ricerche neurobiologiche ci descrivono una mente plastica in continua ridefinizione rispetto alle fasi dello sviluppo e all’ambiente circostante, capace di organizzare moduli comunicativi altamente differenziati”[xxvii].
In secondo luogo, e potremmo dire in contro-tendenza rispetto a Melman, più che marginalizzata o schiacciata sugli altri godimenti, la sessualità è oggi per Preta, oltre che “dislocata”, anche “dislocante”, mai sintetizzabile in un significato univoco, ma sempre decostruttiva, “capace di spiazzare continuamente l’ovvietà delle visioni condivise del sociale.”[xxviii]
In ultimo, ad essere dislocata (e non preclusa) è la proibizione/interdizione, la condizione di limite che costituisce (ed è la condizione affinché vi sia) il desiderio: la questione, insomma, non sta nel proclamare la piatta ed indifferenziata mono-dimensionalità dei godimenti tutti uguali, ma nello scovare dove questa nuova logica del desiderio, questa nuova economia psichica, si situi. Si tratta insomma di cogliere un punto di elaborazione che possa conciliare il chiasma contraddittorio di “una cultura che esalta la <<parzialità>>” ma che, al tempo stesso, “sacrifica l’idea (…) di <<interezza>>”[xxix].
Per qualificare il senso di decentramento odierno, Preta avanza l’idea di un cortocircuito nell’interazione tra la singolarità psichica e il sistema sociale, un’indistinzione tra il mondo interno e quello esterno che si risolve nella “tendenza ad agire l’inconscio”[xxx] attraverso l’evacuazione di frammenti e detriti mentali non elaborati, di cui la cifra più significativa sarebbe proprio l’alessitimia. Questo tipo di configurazione psicopatologica, che alla lettera vuole dire “mancanza di parole per le emozioni”, costituisce la manifestazione principale dello schiacciamento della dimensione immaginaria su quella Reale, del ritiro della capacità di articolazione/elaborazione simbolica, che rende “impossibile” oppure “allucinata” qualsiasi adesione emotiva alla realtà. Sebbene in certi punti il discorso di Preta rischi di degenerare nel “discorso di fine della storia” esaminato poco fa (ad esempio quando nell’Introduzione parla di “una frammentazione disgregante che sembra legata alla pulsione di morte”[xxxi] oppure quando descrive un disarcionamento radicale tra il passato e il presente delle nuove generazioni), trovo nel complesso la sua capacità di de-posizionare la soggettività rispetto alla disarticolazione di ogni frontiera prodotta dalla globalizzazione soddisfacente. Specie quando descrive questo “nuovo soggetto” come “portatore di trasformazioni difficili da misurare [ma non per questo non misurabili] nella loro portata (…), un nuovo individuo, un ibrido, frutto della combinazione di diverse culture.”[xxxii]
Propongo in conclusione di leggere l’evocazione amletica (“Il tempo è fuori dai cardini”) fatta da Preta verso la conclusione del libro non come la spaesante constatazione di un inevitabile deragliamento (morale, simbolico, umanitario ecc.), ma come una vera e propria immagine di kuhniana rottura epistemologica. Del resto, non è forse vero che Gilles Deleuze, nelle Lezioni su Kant, accoglieva la stessa formula per indicare la cessazione del tempo ciclico, cosmologico in favore di una pura ed inaudita forma di tempo dispiegato? Come puntualizza il filosofo francese, questo tipo di decentramento vuol dire anche e anzitutto non essere più “subordinat[i] a qualcosa di altro da se stess[i]”[xxxiii], non essere più preda di un paradigma ormai inadeguato a rispondere degli effetti che la realtà produce sulla nostra ossatura simbolica. Del resto, la rivoluzione freudiana non è stata essa stessa, nella sua radicalità, un inaudito decentramento? Non è stato forse l’avvento dell’inconscio un mettere fuori di sesto l’idea di un soggetto autoriflesso, totalmente trasparente a se stesso e, con esso, quello di una sessualità scandalosa e bestiale?
Insomma, quando Preta afferma che “non è possibile patologizzare questi fenomeni [ma è necessario] creare un tempo <<into the joint>>” ho l’impressione che arrivi a dire che ciò con cui abbiamo a che fare non è attribuibile ipso facto ad una dislocazione unicamente del soggetto, ma anche a quella della stessa psicoanalisi, che oggi più che mai, se vuole resistere senza tradire i propri presupposti, è convocata a rinsaldare i propri cardini, a ri-articolare la propria prospettiva sul mondo che cambia.
Bibliografia
Benvenuto S.
- Confini dell’interpretazione, Teda, Castrovillari, 1988.
- Perversioni, Boringhieri, Torino 2005.
Chiesa L., Contro il discorso della libertà, Orthotes, Napoli-Salerno 2019 (in pubblicazione).
Deleuze G., Fuori dai cardini del tempo. Lezioni su Kant, Mimesis, Milano 2004.
Fachinelli E.
Deleuze G., Fuori dai cardini del tempo. Lezioni su Kant, Mimesis, Milano 2004.
Fachinelli E.
- Al cuore delle cose. Scritti politici (1967-1989), DeriveApprodi, Roma 2016.
- Il bambino dalle uova d’oro, Adelphi, Milano 2010.
Melman C.
- La nuova economia psichica. Il modo di pensare e di godere oggi, Mimesis, Milano 2018.
- L’homme sans gravité, Denoel, 2002.
Preta L. (cur.), Dislocazioni. Nuove forme del disagio psichico e sociale, Mimesis, Milano 2018.
Žižek S.
Žižek S.
- Chiedere l’impossibile, Ombre Corte, Verona 2013.
- Like a thief in broad daylight, Allen Lane, London 2018.
Zupančič A., Che cosa è il sesso?, Ponte alle Grazie, Milano 2018.
[i] S. Benvenuto (1988), p. 82.
[ii] Ivi, p. 84.
[iii] Cfr. S. Žižek (2013), p. 15.
[iv] S. Benvenuto (1988), pp. 82-83.
[v] Per una complessiva introduzione a questi fenomeni, si veda il Capitolo 1 (The State of Things) in S. Žižek (2018), pp. 13-56
[vi] Cfr. C. Melman (2002) e C. Melman (2018).
[vii] Più precisamente, possiamo caratterizzare la “nexologia” come un approccio a due livelli. Ad un primo livello, come scrive Dario Borso, “per Fachinelli dunque non si trattava né di integrare il dettato freudiano ibridandolo ad altre <<scienze>>, né di restaurarlo nella sua ortodossa purezza” (Cfr. D. Borso, Premessa in E. Fachinelli (2016), pp. 5-6), ma di trovare una “terza via” tra e da le due. Ad un secondo e più radicale livello, essa mira a conciliare le acquisizioni individuali psicoanalitiche con un campo di ricerca interindividual bio-psico-sociale, di cui la psicoanalisi stessa rappresenterebbe “solo un momento parziale, limitato, anche se di grande fecondità” (Cfr. E. Fachinelli (2010), p. 282).
[viii] C. Melman (2002), p. 24.
[ix] C. Melman (2018), p. 62.
[x] Ivi, p. 64.
[xi] Ivi, p. 61.
[xii] Ivi, p. 51.
[xiii] Cfr. la Postfazione Libertà, umanismo, fine della storia: Gioele P. Cima intervista Lorenzo Chiesa in L. Chiesa (2019) p. 174 (in pubblicazione).
[xiv] S. Žižek (2018), p. 211.
[xv] V. Lingiardi, Senza mappe per questi territori, in L. Preta (2018), p. 23.
[xvi] Ivi, p. 22.
[xvii] Ivi, p. 23.
[xviii] Ivi, p. 27.
[xix] Ivi, p. 26.
[xx] A. Zupančič (2018), p. 16.
[xxi] Ultimamente, sull’argomento è intervenuto anche Sergio Benvenuto, che da anni ormai si occupa di ciò che potremmo chiamare le “aporie nosografiche” del DSM, con particolare attenzione alle cosiddette parafilie. Si veda in particolare: http://www.psychiatryonline.it/node/7778. Per una trattazione concettuale più estesa dell’argomento delle parafilie ed una loro analisi antropologica, segnalo anche S. Benvenuto (2005).
[xxii] G. Homayounpour, Esperienze di transgenderismo in Iran, in L. Preta (2018), p. 35.
[xxiii] Ivi, p. 36.
[xxiv] Ivi, p. 48.
[xxv] Ibidem.
[xxvi] L. Preta, Introduzione in L. Preta (2018), p. 10.
[xxvii] Ivi, p. 11.
[xxviii] Ivi, p. 12.
[xxix] Ivi, p. 14.
[xxx] L. Preta, <<The time is out of joint>>. Nuove soggettività, in L. Preta (2018), p. 102.
[xxxi] L. Preta, Introduzione in L. Preta (2018), p.15.
[xxxii] L. Preta, <<The time is out of joint>>. Nuove soggettività, in L. Preta (2018), p. 99.
[xxxiii] G. Deleuze (2004), p. 72.








